La rigenerazione come proprietà degli esseri viventi: la capacità di autorinnovamento e ripristino. Tipi di rigenerazione
RIGENERAZIONE
ripristino da parte del corpo delle parti perdute in una o nell'altra fase del ciclo di vita. La rigenerazione avviene solitamente in caso di danno o perdita di un organo o di una parte del corpo. Tuttavia, oltre a ciò, processi di ripristino e rinnovamento avvengono costantemente in ogni organismo durante tutta la sua vita. Negli esseri umani, ad esempio, lo strato esterno della pelle viene costantemente rinnovato. Gli uccelli periodicamente perdono le piume e ne crescono di nuove, mentre i mammiferi cambiano la pelliccia. Gli alberi decidui perdono le foglie ogni anno e vengono sostituite con foglie fresche. Tale rigenerazione, solitamente non associata a danno o perdita, è chiamata fisiologica. La rigenerazione che avviene dopo il danno o la perdita di qualsiasi parte del corpo è chiamata riparativa. Qui considereremo solo la rigenerazione riparativa. La rigenerazione riparativa può essere tipica o atipica. Nella rigenerazione tipica, la parte perduta viene sostituita dallo sviluppo della stessa identica parte. La causa della perdita può essere una forza esterna (ad esempio l'amputazione), oppure l'animale può strapparsi deliberatamente una parte del corpo (autotomia), come una lucertola che si stacca parte della coda per sfuggire a un nemico. Con la rigenerazione atipica, la parte perduta viene sostituita da una struttura che differisce dall'originale quantitativamente o qualitativamente. L'arto rigenerato di un girino può avere meno dita di quello originale e un gambero può sviluppare un'antenna invece di un occhio amputato.
RIGENERAZIONE NEGLI ANIMALI
La capacità di rigenerarsi è molto diffusa tra gli animali. In generale, gli animali inferiori sono più spesso capaci di rigenerarsi rispetto alle forme più complesse e altamente organizzate. Pertanto, tra gli invertebrati esistono molte più specie in grado di ripristinare gli organi perduti che tra i vertebrati, ma solo in alcuni di essi è possibile rigenerare un intero individuo da un piccolo frammento. Tuttavia la regola generale secondo cui la capacità di rigenerarsi diminuisce con l’aumentare della complessità dell’organismo non può essere considerata assoluta. Animali primitivi come ctenofori e rotiferi sono praticamente incapaci di rigenerarsi, ma in crostacei e anfibi molto più complessi questa capacità è ben espressa; Sono note altre eccezioni. Alcuni animali strettamente imparentati differiscono notevolmente sotto questo aspetto. Pertanto, in un lombrico, un nuovo individuo può rigenerarsi completamente da un piccolo pezzo del suo corpo, mentre le sanguisughe non sono in grado di ripristinare un organo perduto. Negli anfibi dalla coda, si forma un nuovo arto al posto dell'arto amputato, ma nella rana il moncone semplicemente guarisce e non si verifica alcuna nuova crescita. Molti invertebrati sono in grado di rigenerare gran parte del loro corpo. Nelle spugne, nei polipi idroidi, nei platelminti, nelle tenie e negli anellidi, nei briozoi, negli echinodermi e nei tunicati, un intero organismo può rigenerarsi da un piccolo frammento del corpo. Particolarmente degna di nota è la capacità di rigenerarsi delle spugne. Se il corpo di una spugna adulta viene premuto attraverso il tessuto a rete, tutte le cellule si separeranno l'una dall'altra, come se fossero setacciate al setaccio. Se poi metti tutte queste singole cellule in acqua e le mescoli attentamente e accuratamente, distruggendo completamente tutte le connessioni tra loro, dopo un po 'iniziano ad avvicinarsi gradualmente e a riunirsi, formando un'intera spugna, simile alla precedente. Ciò comporta una sorta di "riconoscimento" a livello cellulare, come evidenziato dal seguente esperimento. Spugne di tre specie diverse sono state separate in cellule separate nel modo descritto e mescolate accuratamente. Allo stesso tempo, si scoprì che le cellule di ciascuna specie sono in grado di “riconoscere” le cellule della propria specie nella massa totale e di riunirsi solo con esse, tanto che di conseguenza non una, ma tre nuove spugne furono formato, simile ai tre originali.
La tenia, che è molte volte più lunga che larga, può ricreare un intero individuo da qualsiasi parte del suo corpo. In teoria è possibile, tagliando un verme in 200.000 pezzi, ottenere da esso 200.000 nuovi vermi come risultato della rigenerazione. Da un raggio di una stella marina può rigenerarsi un'intera stella.

Molluschi, artropodi e vertebrati non sono in grado di rigenerare un intero individuo da un frammento, tuttavia in molti di essi l'organo perduto viene ripristinato. Alcuni ricorrono all'autotomia, se necessario. Uccelli e mammiferi, essendo gli animali evolutivamente più avanzati, sono meno capaci di rigenerarsi rispetto ad altri. Negli uccelli è possibile sostituire le piume e alcune parti del becco. I mammiferi possono ripristinare il tegumento, gli artigli e in parte il fegato; sono anche in grado di curare le ferite e i cervi sono in grado di far crescere nuove corna per sostituire quelle capannone.
Processi di rigenerazione. Due processi sono coinvolti nella rigenerazione negli animali: epimorfosi e morfallassi. Nella rigenerazione epimorfica, la parte perduta del corpo viene ripristinata grazie all'attività delle cellule indifferenziate. Queste cellule simili all'embrione si accumulano sotto l'epidermide ferita sulla superficie tagliata, dove formano il primordio o blastema. Le cellule del blastema si moltiplicano gradualmente e si trasformano nel tessuto di un nuovo organo o parte del corpo. Nella morfallassi, altri tessuti del corpo o dell'organo vengono trasformati direttamente nelle strutture della parte mancante. Nei polipi idroidi, la rigenerazione avviene principalmente attraverso la morfallassi, mentre nelle planarie sono coinvolte contemporaneamente sia l'epimorfosi che la morfallassi. La rigenerazione mediante formazione di blastema è diffusa negli invertebrati e svolge un ruolo particolarmente importante nella rigenerazione degli organi negli anfibi. Esistono due teorie sull'origine delle cellule di blastema: 1) le cellule di blastema provengono da “cellule di riserva”, cioè cellule rimaste inutilizzate durante lo sviluppo embrionale e distribuite tra i diversi organi del corpo; 2) i tessuti, la cui integrità è stata violata durante l'amputazione, “dedifferenziati” nell'area dell'incisione, ad es. disintegrarsi e trasformarsi in singole cellule di blastema. Quindi, secondo la teoria delle “cellule di riserva”, il blastema è formato da cellule rimaste embrionali, che migrano da diverse parti del corpo e si accumulano in prossimità della superficie tagliata, e secondo la teoria del “tessuto dedifferenziato”, le cellule del blastema provengono da cellule dei tessuti danneggiati. Ci sono dati sufficienti per supportare sia l’una che l’altra teoria. Ad esempio, nelle planarie, le cellule di riserva sono più sensibili ai raggi X rispetto alle cellule di tessuto differenziato; pertanto, possono essere distrutti dosando rigorosamente le radiazioni in modo da non danneggiare il normale tessuto planario. Gli individui irradiati in questo modo sopravvivono, ma perdono la capacità di rigenerarsi. Tuttavia, se viene irradiata e poi tagliata solo la metà anteriore del corpo planare, si verifica la rigenerazione, anche se con un certo ritardo. Il ritardo indica che il blastema è formato da cellule di riserva che migrano verso la superficie tagliata dalla metà non irradiata del corpo. La migrazione di queste cellule di riserva in tutta la parte del corpo irradiata può essere osservata al microscopio. Esperimenti simili hanno dimostrato che nel tritone la rigenerazione degli arti avviene grazie a cellule di blastema di origine locale, cioè a causa della dedifferenziazione dei tessuti del moncone danneggiato. Se, ad esempio, si irradia l'intera larva del tritone tranne, diciamo, la zampa anteriore destra, e poi si amputa quell'arto a livello dell'avambraccio, all'animale crescerà una nuova zampa anteriore. È ovvio che le cellule del blastema necessarie a questo scopo provengono proprio dal moncone della zampa anteriore, poiché il resto del corpo è stato irradiato. Inoltre, la rigenerazione avviene anche se viene irradiata l'intera larva, ad eccezione di un'area larga 1 mm sul tarso anteriore destro, e poi quest'ultimo viene amputato praticando un'incisione attraverso questa area non irradiata. In questo caso è abbastanza chiaro che le cellule del blastema provengono dalla superficie tagliata, poiché l'intero corpo, compresa la zampa anteriore destra, è stato privato della capacità di rigenerarsi. I processi descritti sono stati analizzati utilizzando metodi moderni. Un microscopio elettronico consente di osservare in tutti i dettagli i cambiamenti nei tessuti danneggiati e in rigenerazione. Sono stati creati coloranti che rivelano alcune sostanze chimiche contenute nelle cellule e nei tessuti. I metodi istochimici (utilizzando coloranti) consentono di giudicare i processi biochimici che si verificano durante la rigenerazione di organi e tessuti.
Polarità. Uno dei problemi più misteriosi della biologia è l'origine della polarità negli organismi. Dall'uovo sferico di una rana si sviluppa un girino, che fin dall'inizio ha una testa con cervello, occhi e bocca a un'estremità del corpo e una coda all'altra. Allo stesso modo, se tagli il corpo di una planaria in singoli frammenti, si svilupperà una testa a un'estremità di ciascun frammento e una coda all'altra. In questo caso la testa si forma sempre all'estremità anteriore del frammento. Gli esperimenti mostrano chiaramente che la planaria ha un gradiente di attività metabolica (biochimica) lungo l'asse antero-posteriore del suo corpo; in questo caso, l'attività massima si verifica all'estremità anteriore del corpo, mentre verso l'estremità posteriore l'attività diminuisce gradualmente. In qualsiasi animale la testa si forma sempre all'estremità del frammento dove l'attività metabolica è maggiore. Se la direzione del gradiente dell'attività metabolica in un frammento isolato di planaria viene invertita, la formazione della testa avverrà all'estremità opposta del frammento. Il gradiente dell'attività metabolica nel corpo delle planarie riflette l'esistenza di un gradiente fisico-chimico più importante, la cui natura è ancora sconosciuta. Nell'arto rigenerante di un tritone, la polarità della struttura appena formata sembra essere determinata dal moncone conservato. Per ragioni ancora poco chiare, nell'organo rigenerante si formano solo le strutture distali rispetto alla superficie della ferita, mentre quelle situate più prossimalmente (più vicine al corpo) non si rigenerano mai. Quindi, se la mano di un tritone viene amputata e la parte rimanente della zampa anteriore viene inserita con l'estremità tagliata nella parete del corpo e questa estremità distale (distante dal corpo) può mettere radici in un posto nuovo e insolito per esso, quindi la successiva sezione di questo arto superiore in prossimità della spalla (liberandolo dal collegamento con la spalla) porta alla rigenerazione dell'arto con un insieme completo di strutture distali. Al momento del taglio tale arto presenta le seguenti parti (a partire dal polso, fuso con la parete corporea): polso, avambraccio, gomito e metà distale della spalla; poi, a seguito della rigenerazione, compaiono: un'altra metà distale della spalla, gomito, avambraccio, polso e mano. Pertanto, l'arto invertito (capovolto) ha rigenerato tutte le parti situate distalmente alla superficie della ferita. Questo fenomeno sorprendente indica che i tessuti del moncone (in questo caso il moncone dell'arto) controllano la rigenerazione dell'organo. Il compito di ulteriori ricerche è quello di scoprire esattamente quali fattori controllano questo processo, cosa stimola la rigenerazione e cosa provoca l'accumulo delle cellule che assicurano la rigenerazione sulla superficie della ferita. Alcuni scienziati ritengono che il tessuto danneggiato rilasci una sorta di "fattore ferita" chimico. Tuttavia, non è stato ancora possibile isolare una sostanza chimica specifica per le ferite.
RIGENERAZIONE NELLE PIANTE
La diffusione diffusa della rigenerazione nel regno vegetale è dovuta alla conservazione dei meristemi (tessuti costituiti da cellule in divisione) e dei tessuti indifferenziati. Nella maggior parte dei casi, la rigenerazione delle piante è, in sostanza, una delle forme di propagazione vegetativa. Pertanto, sulla punta di uno stelo normale si trova una gemma apicale, che assicura la continua formazione di nuove foglie e la crescita dello stelo in lunghezza per tutta la vita della pianta. Se questa gemma viene recisa e mantenuta umida, spesso si sviluppano nuove radici dalle cellule del parenchima in essa presenti o dal callo formatosi sulla superficie del taglio; il germoglio continua a crescere e dà origine ad una nuova pianta. La stessa cosa accade in natura quando un ramo si spezza. Le ciglia e gli stoloni si separano a causa della morte delle vecchie sezioni (internodi). Allo stesso modo si dividono i rizomi dell'iris, della zampa di lupo o delle felci, formando nuove piante. Tipicamente i tuberi, come quelli della patata, continuano a vivere dopo la morte del fusto sotterraneo su cui crescevano; con l'inizio di una nuova stagione di crescita, possono dare origine alle proprie radici e germogli. Nelle piante bulbose, come i giacinti o i tulipani, i germogli si formano alla base delle scaglie del bulbo e possono a loro volta formare nuovi bulbi, che alla fine producono radici e steli fioriferi, cioè. diventare piante indipendenti. In alcuni gigli si formano bulbi aerei nelle ascelle delle foglie e in un certo numero di felci crescono germogli di covata sulle foglie; ad un certo punto cadono a terra e riprendono la crescita. Le radici sono meno capaci di formare nuove parti rispetto agli steli. Per questo il tubero della dalia necessita di un bocciolo che si forma alla base del fusto; tuttavia, le patate dolci possono dare origine ad una nuova pianta da un germoglio formato da un cono radicale. Le foglie sono anche capaci di rigenerarsi. In alcune specie di felci, ad esempio nella felce (Camptosorus), le foglie sono molto allungate e sembrano lunghe strutture simili a peli terminanti con un meristema. Da questo meristema si sviluppa l'embrione con fusto, radici e foglie rudimentali; se la punta della foglia della pianta madre si piega e tocca il terreno o il muschio, il germoglio inizia a crescere. La nuova pianta si separa dalla madre dopo l'esaurimento di questa formazione simile a un capello. Le foglie della succulenta pianta d'appartamento Kalanchoe portano ai bordi piantine ben sviluppate che cadono facilmente. Nuovi germogli e radici si formano sulla superficie delle foglie di begonia. Corpi speciali chiamati gemme embrionali si sviluppano sulle foglie di alcuni muschi club (Lycopodium) ed epatiche (Marchantia); cadendo al suolo, attecchiscono e formano nuove piante mature. Molte alghe si riproducono con successo rompendosi in frammenti sotto l'impatto delle onde.
Guarda anche SISTEMATICA VEGETALE. LETTERATURA Mattson P. Rigenerazione: presente e futuro. M., 1982 Gilbert S. Biologia dello sviluppo, vol. 1-3. M., 1993-1995
Enciclopedia di Collier. - Società aperta. 2000 .
Sinonimi:Scopri cos'è "RIGENERAZIONE" in altri dizionari:
RIGENERAZIONE- RIGENERAZIONE, il processo di formazione di un nuovo organo o tessuto al posto di una parte del corpo che è stata in un modo o nell'altro rimossa. Molto spesso R. viene definito come il processo di ripristino di ciò che è andato perduto, cioè la formazione di un organo simile a quello asportato. Questo... ... Grande Enciclopedia Medica
- (tardo lat., dal lat. re ancora, ancora, e genere, eris genere, generazione). Rinascita, rinnovamento, restauro di ciò che è stato distrutto. In senso figurato: un cambiamento in meglio. Dizionario delle parole straniere incluse nella lingua russa.... ... Dizionario delle parole straniere della lingua russa
RIGENERAZIONE, in biologia, la capacità del corpo di sostituire una delle parti perdute. Il termine rigenerazione si riferisce anche a una forma di riproduzione asessuata in cui un nuovo individuo nasce da una parte separata del corpo della madre... Dizionario enciclopedico scientifico e tecnico
Restauro, recupero; compensazione, rigenerazione, rinnovamento, eteromorfosi, pettencoferazione, rinascita, morfallassi Dizionario dei sinonimi russi. sostantivo rigenerazione, numero di sinonimi: 11 compensazione (20) ... Dizionario dei sinonimi
1) ripristino, mediante determinati processi fisico-chimici, della composizione e delle proprietà originali dei prodotti di scarto per il loro riutilizzo. Negli affari militari, la rigenerazione dell'aria è diventata molto diffusa (specialmente sui subacquei... ... Dizionario marino
Rigenerazione- – riportando il prodotto usato alle sue proprietà originali. [Dizionario terminologico del calcestruzzo e del cemento armato. FSUE "Centro di ricerca "Costruzione" NIIZHB dal nome. A. A. Gvozdeva, Mosca, 2007, 110 pp.] Rigenerazione - ripristino dei rifiuti... ... Enciclopedia dei termini, definizioni e spiegazioni dei materiali da costruzione
RIGENERAZIONE- (1) ripristino delle proprietà originarie e della composizione dei materiali di scarto (acqua, aria, oli, gomma, ecc.) per il loro riutilizzo. Viene effettuato con l'aiuto di determinati fisici chimico. processi in speciali dispositivi rigeneratori. Largo... ... Grande Enciclopedia del Politecnico
- (dal tardo lat. rigeneratio rinascita rinnovamento), in biologia, il ripristino da parte del corpo di organi e tessuti perduti o danneggiati, nonché il ripristino dell'intero organismo da parte sua. Caratteristico soprattutto delle piante e degli invertebrati... ...
Nella tecnologia, ad esempio, 1) riportare il prodotto esaurito alle sue qualità originali. ripristino delle proprietà della sabbia esaurita di formatura nelle fonderie, purificazione dell'olio lubrificante usato, trasformazione di prodotti in gomma usurati in plastica... ... Grande dizionario enciclopedico
RIGENERAZIONE, rigenerazione, tante. no, femmina (lat. rigeneratio restauro, ritorno). 1. Riscaldamento del gas e dell'aria che entrano nel forno con prodotti della combustione dei rifiuti (tecnici). 2. Riproduzione di organi perduti da parte di animali (zool.). 3. Radiazioni... ... Dizionario esplicativo di Ushakov
Rigenerazione(dal lat. rigenerazione- rinascita) è il processo di ripristino delle strutture biologiche durante la vita di un organismo. La rigenerazione mantiene la struttura e le funzioni del corpo, la sua integrità. I processi di rigenerazione sono implementati a diversi livelli di organizzazione: genetico molecolare, subcellulare, cellulare, tessuto, organo, organismo. A livello genetico molecolare, la replicazione del DNA, la sua riparazione, la sintesi di vengono prodotti nuovi enzimi, molecole di ATP, ecc. Tutti questi processi sono inclusi nel metabolismo della cellula. A livello subcellulare, le strutture cellulari vengono ripristinate grazie alla formazione di nuove unità strutturali e all'assemblaggio di organelli o alla divisione degli organelli sopravvissuti. Ad esempio, le strutture mobili della membrana cellulare - recettori, canali ionici e pompe - possono muoversi, concentrarsi o distribuirsi all'interno della membrana. Inoltre, lasciano la membrana, vengono distrutti e sostituiti da nuovi. Pertanto, nei mioblasti, circa 1 µm2 della superficie viene degradata e sostituita da nuove molecole ogni minuto. Nelle cellule fotorecettrici - bastoncelli (Fig. 8.73) c'è un segmento esterno costituito da circa un migliaio di cosiddetti dischi fotorecettori - sezioni densamente imballate della membrana cellulare in cui sono immerse le proteine sensibili alla luce associate al pigmento visivo. Questi dischi si rinnovano continuamente: si degradano all'estremità esterna e riappaiono all'estremità interna ad una velocità di 3-4 dischi all'ora. I processi di recupero dopo il danno vengono eseguiti in modo simile. L'esposizione ai veleni mitocondriali provoca la perdita delle creste mitocondriali. Dopo la cessazione dell'azione del veleno nella cellula epatica, i mitocondri ripristinano la loro struttura in 2-3 giorni.Il livello di rigenerazione cellulare implica il ripristino della struttura e, in alcuni casi, delle funzioni della cellula. Esempi di questo tipo includono il ripristino del processo di una cellula nervosa di un neurone. Nei mammiferi, questo processo avviene ad una velocità di 1 mm al giorno. Il ripristino delle funzioni cellulari può essere ottenuto attraverso iperplasia- aumento del numero di organelli intracellulari (rigenerazione intracellulare).Al livello successivo - tessuto o popolazione cellulare - avviene il rifornimento delle cellule perse di una certa direzione di differenziazione. Le ristrutturazioni avvengono all'interno delle popolazioni cellulari e il loro risultato è il ripristino delle funzioni dei tessuti. Pertanto, nell'uomo, la durata della vita delle cellule epiteliali intestinali è di 4-5 giorni, delle piastrine - 5-7 giorni, degli eritrociti - 120-125 giorni. Ogni secondo circa 1 milione di globuli rossi vengono distrutti e la stessa quantità si forma nuovamente nel midollo osseo rosso. La capacità di ripristinare le cellule perse è garantita dal fatto che nei tessuti sono presenti due compartimenti cellulari. Una è costituita dalle cellule operaie differenziate e l'altra sono le cellule cambiali capaci di divisione e successiva differenziazione. Queste ultime vengono attualmente chiamate cellule staminali regionali (vedi paragrafi 3.1.2, 3.2). Sono impegnati, cioè il loro destino è predeterminato (vedi paragrafo 8.3.1), quindi sono in grado di dare origine a uno o più tipi cellulari specifici. La loro ulteriore differenziazione è determinata da segnali provenienti dall'esterno: dall'ambiente (interazioni intercellulari) e segnali distanti (ad esempio ormoni), a seconda di quali geni specifici vengono attivati selettivamente nelle cellule. Pertanto, nell'epitelio dell'intestino tenue, le cellule cambiali si trovano nelle zone inferiori delle cripte (Fig. 8.74). Sotto determinate influenze, sono in grado di dare origine alle cellule dell'epitelio assorbente “marginale” e ad alcune ghiandole unicellulari.Il livello di rigenerazione dell'organo comporta il ripristino della funzione o della struttura dell'organo. A questo livello si osservano non solo trasformazioni delle popolazioni cellulari, ma anche processi morfogenetici. In questo caso vengono implementati gli stessi meccanismi della formazione degli organi nell'embriogenesi. Ta- Riso. 8.73. Rappresentazione schematica del fotorecettore retinico - bastoncelli: 1 - corpo sinaptico adiacente allo strato neurale della retina, 2 - nucleo, 3 - apparato di Golgi, 4 - segmento interno con mitocondri, 5 - ciglio di collegamento, 6 - segmento esterno con dischi fotorecettori che tipo di rigenerazione può essere effettuataepimorfosi, morfolassi, ipertrofia rigenerativa.Questimetodi e meccanismi di rigenerazione sono discussi di seguito. A livello dell'organismo, in alcuni casi è possibile ricreare un intero organismo da una o da un gruppo di cellule. Esistono due tipi di rigenerazione:fisiologicoEriparativo.Rigenerazione fisiologica (omeostatica).è il processo di ripristino delle strutture che si usurano durante la vita normale. Grazie ad esso viene mantenuta l’omeostasi strutturale e gli organi possono svolgere costantemente le loro funzioni. Da un punto di vista biologico generale, la rigenerazione fisiologica, come il metabolismo, è una manifestazione di una proprietà così importante della vita come l'autorinnovamento. L'autorinnovamento garantisce l'esistenza dell'organismo nel tempo e nello spazio. Si basa sulla migrazione biogenica degli atomi. A livello intracellulare, l’importanza della rigenerazione fisiologica è particolarmente grande per i tessuti cosiddetti “eterni” che hanno perso la capacità di rigenerarsi attraverso la divisione cellulare. Questo vale innanzitutto per il tessuto nervoso, la retina. A livello cellulare e tissutale, la rigenerazione fisiologica avviene nei tessuti “labili”, dove Riso. 8.74. Localizzazione delle cellule staminali regionali nell'epitelio dell'intestino tenue: 1 - cellule che non si dividono; 2 - divisione delle cellule staminali; 3 - cellule che si dividono rapidamente; 4 - cellule differenziate che non si dividono; 5 — direzione del movimento delle cellule; 6 - cellule esfoliate dalla superficie dei villi intestinali; l'intensità del rinnovamento cellulare è molto elevata e nei tessuti “in crescita”, le cui cellule si rinnovano molto più lentamente. Il primo gruppo comprende, ad esempio, la cornea dell'occhio, l'epitelio della mucosa intestinale, le cellule del sangue periferico, l'epidermide della pelle e i suoi derivati: capelli e unghie. Le cellule di organi come il fegato, i reni e le ghiandole surrenali costituiscono il secondo di questi gruppi. L'intensità della proliferazione è giudicata dal numero di mitosi per 1000 cellule contate. Se consideriamo che la mitosi stessa dura in media circa 1 ora, e l'intero ciclo mitotico nelle cellule somatiche dura in media 22-24 ore, diventa chiaro che per determinare l'intensità del rinnovamento della composizione cellulare dei tessuti, è necessario necessario contare il numero di mitosi nell'arco di uno o più giorni. Si è scoperto che il numero di cellule che si dividono non è lo stesso nei diversi momenti della giornata. È così che è stato scoperto il ritmo quotidiano della divisione cellulare, un esempio del quale è mostrato in Fig. 8.75 Un ritmo giornaliero nel numero delle mitosi è stato riscontrato non solo nei tessuti normali, ma anche in quelli tumorali. Riflette un modello più generale, Riso. 8,75. Cambiamenti giornalieri dell'indice mitotico (MI) nell'epitelio dell'esofago (1) e della cornea (2) dei topi. L'indice mitotico è espresso in ppm (0/00), che riflette il numero di mitosi in mille cellule contate vale a dire, il ritmo di tutte le funzioni del corpo. Una delle aree moderne della biologia ècronobiologia— studia, in particolare, i meccanismi di regolazione dei ritmi quotidiani dell'attività mitotica, che è di grande importanza per la medicina. L'esistenza di una periodicità giornaliera nel numero di mitosi indica la possibilità di regolazione della rigenerazione fisiologica da parte dell'organismo. Oltre ai cicli giornalieri, ci sono cicli lunari e annuali di rinnovamento dei tessuti e degli organi. La rigenerazione fisiologica è inerente agli organismi di tutte le specie, ma avviene in modo particolarmente intenso nei vertebrati a sangue caldo, poiché generalmente hanno un'intensità di funzionamento di tutti gli organi molto elevata rispetto ad altri animali. Rigenerazione riparativa(dal lat.riparazione - restauro) - ripristino delle strutture biologiche dopo lesioni e altri fattori dannosi. Tali fattori possono includere sostanze tossiche, agenti patogeni, alte e basse temperature (ustioni e congelamenti), esposizione alle radiazioni, digiuno, ecc. La capacità di rigenerarsi non dipende chiaramente dal livello di organizzazione, anche se è stato notato da tempo che gli animali meno organizzati hanno una migliore capacità di rigenerare gli organi esterni. Ciò è confermato da sorprendenti esempi di rigenerazione di idra, planarie, anellidi, artropodi, echinodermi e cordati inferiori, come le ascidie. Tra i vertebrati, gli anfibi dalla coda hanno la migliore capacità rigenerativa. È noto che specie diverse della stessa classe possono differire notevolmente nella loro capacità di rigenerarsi. Inoltre, studiando la capacità di rigenerare gli organi interni, si è scoperto che è significativamente più alta negli animali a sangue caldo, come i mammiferi, rispetto agli anfibi. La rigenerazione nei mammiferi è unica. Per la rigenerazione di alcuni organi esterni sono necessarie condizioni speciali. La lingua e l'orecchio, ad esempio, non si rigenerano con danni marginali (si parla infatti di amputazione della parte marginale della struttura). Se si applica un difetto passante su tutto lo spessore dell'organo, il recupero procede bene. La rigenerazione degli organi interni può essere molto attiva. Da un piccolo frammento dell'ovaio viene ricostruito un intero organo. Si presume che l'impossibilità di rigenerazione degli arti e di altri organi esterni nei mammiferi sia di natura adattiva e sia dovuta alla selezione, poiché con uno stile di vita attivo, i processi morfogenetici che richiedono una regolazione complessa renderebbero difficile l'esistenza. Numerosi ricercatori ritengono che originariamente gli organismi avessero due modi per guarire le ferite: l'azione del sistema immunitario e la rigenerazione. Ma nel corso dell'evoluzione sono diventati incompatibili tra loro. Sebbene la rigenerazione possa sembrare una scelta migliore, ciò che è più importante per noi sono le cellule T del sistema immunitario, la nostra arma principale contro i tumori. La rigenerazione di un arto diventa inutile se contemporaneamente le cellule tumorali si sviluppano rapidamente nel corpo. Si scopre che il sistema immunitario, mentre ci protegge dalle infezioni e dal cancro, sopprime contemporaneamente la nostra capacità di recupero. Il volume della rigenerazione riparativa può essere molto diverso. Un'opzione estrema è il ripristino dell'intero organismo da una piccola parte separata di esso , in realtà da un gruppo di cellule somatiche. Tra gli animali, tale ripristino è possibile nelle spugne e nei celenterati. L'idra può essere rigenerata da un gruppo di cellule ottenute pressandola attraverso un setaccio. Tra le piante, lo sviluppo di una pianta completamente nuova è possibile anche da una cellula somatica, come è stato ottenuto con l'esempio delle carote e del tabacco. Questo tipo di processi di ripristino è accompagnato dall'emergere di un nuovo asse morfogenetico del corpo e si chiama B.P. Tokin “embriogenesi somatica”, poiché per molti aspetti somiglia allo sviluppo embrionale. Come opzione simile per la rigenerazione, si può prendere in considerazione la clonazione sperimentale di un intero organismo da una cellula somatica nei mammiferi.L'opzione successiva in termini di portata è il ripristino di ampie aree del corpo costituite da un complesso di organi. Un esempio è la rigenerazione nell'idra, nel verme ciliato (planaria) e nelle stelle marine (Fig. 8.76). Rimuovendo parte dell'animale dal frammento rimanente, anche molto piccolo, è possibile ripristinare un organismo a tutti gli effetti. Ad esempio, il restauro di una stella marina da una razza conservata.Segue in questa serie la rigenerazione dei singoli organi, che è diffusa nel regno animale, ad esempio la coda di una lucertola, gli occhi degli artropodi, l'occhio, gli arti , e la coda di un tritone.La guarigione della pelle, delle ferite, delle ossa e di altri organi interni è il processo meno esteso, ma non per questo meno importante per ripristinare l'integrità strutturale e funzionale del corpo.Esistono diversi metodi di rigenerazione riparativa. Questi includono epimorfosi, morfallassi, ipertrofia rigenerativa, ipertrofia compensatoria, guarigione delle ferite epiteliali, rigenerazione dei tessuti. Riso. 8.76. Rigenerazione di un complesso di organi in alcune specie di animali invertebrati: a - idra; b - verme piatto; c - stella marina; d - ripristino di una stella marina da un raggio Epimorfosiè il metodo di rigenerazione più evidente, consistente nella crescita di un nuovo organo dalla superficie dell'amputazione. Un esempio è la rigenerazione del cristallino o dell'arto negli anfibi dalla coda (Fig. 8.77). Consideriamo più in dettaglio il processo di rigenerazione usando l'esempio dell'epimorfosi dell'arto del tritone. Durante il processo di recupero si distinguono fasi regressive e progressive di rigenerazione. La fase di regressione inizia con la guarigione della ferita, durante la quale si verificano i seguenti eventi principali: arresto Riso. 8.77. Rigenerazione del cristallino (1) dell'iride dorsale (2) in caso di sanguinamento da tritone, contrazione dei tessuti molli del moncone dell'arto, formazione di un coagulo di fibrina sulla superficie della ferita e migrazione dell'epidermide che ricopre la superficie dell'amputazione, quindi distruzione dei tessuti inizia immediatamente prossimale al sito di amputazione. Allo stesso tempo, le cellule coinvolte nel processo infiammatorio penetrano nei tessuti molli distrutti, si osservano fagocitosi ed edema locale. Successivamente inizia la dedifferenziazione delle cellule specializzate nell'area sotto l'epidermide della ferita: muscolo, osso, cartilagine, ecc. Le cellule acquisiscono caratteristiche mesenchimali, formano un grappolo e si formano blastema rigenerativo(Fig. 8.78). Allo stesso tempo, l'epidermide della ferita si ispessisce e si forma rapidamente cappuccio ectodermico apicale. In questa fase, i vasi e le fibre nervose crescono nel blastema rigenerativo e nel cappuccio ectodermico, poi inizia la fase progressiva, che è maggiormente caratterizzata dai processi di crescita e morfogenesi. La lunghezza e il peso del blastema rigenerativo aumentano rapidamente. Assume una forma conica. Le cellule mesenchimali del blastema si dedifferenziano dando origine a tutti i tipi cellulari specializzati necessari a formare le strutture dell'arto. Ha luogo la crescita dell'arto e la sua morfogenesi (formazione della forma). Quando la forma generale dell'arto si è già sviluppata, l'arto rigenerato è ancora più piccolo dell'arto normale. Più grande è l'animale, maggiore è questa differenza di dimensioni. Il completamento della morfogenesi richiede tempo, dopo il quale il rigenerato raggiunge le dimensioni di un arto normale. Alcune fasi del ripristino dell'arto anteriore in un tritone dopo l'amputazione a livello della spalla sono mostrate in Fig. 8.79. Riso. 8.78. Rigenerazione di un arto in un tritone: a - arto normale, b - amputazione; c — formazione del cappuccio apicale e blastema; d — ridifferenziazione cellulare; d - arto appena formato. 1 - blastema; 2 - cappuccio ectodermico apicale; 3 - ridifferenziazione delle cellule di blastema (spiegazioni nel testo) Nelle giovani larve di axolotl, l'arto può rigenerarsi in 3 settimane, nei tritoni adulti e negli axolotl - in 1-2 mesi, e negli ambistos terrestri ciò richiede circa 1 anno. Morfallassi— rigenerazione mediante ristrutturazione dell'area rigenerante. Un esempio è la rigenerazione di un'idra da un anello tagliato dalla metà del suo corpo, o il ripristino di una planaria da un decimo o ventesimo della sua parte. In questo caso non si verificano processi di modellamento significativi sulla superficie della ferita. Il pezzo tagliato si restringe, le cellule al suo interno si riorganizzano e appare un intero individuo di dimensioni ridotte, che poi cresce. Questo metodo di rigenerazione fu descritto per la prima volta da T. Morgan nel 1900. Secondo la sua descrizione, la morfallassi avviene senza mitosi. Spesso c'è una combinazione di crescita epimorfica nel sito di amputazione con riorganizzazione attraverso morfallassi nelle parti adiacenti del corpo. Ipertrofia rigenerativa (endomorfosi) si riferisce agli organi interni. Questo metodo di rigenerazione comporta l’aumento delle dimensioni dell’organo rimanente senza ripristinarne la forma originale. Un esempio è la rigenerazione del fegato dei vertebrati, compresi i mammiferi. Con una lesione marginale al fegato, la parte rimossa dell'organo non viene mai ripristinata. La superficie della ferita sta guarendo. Allo stesso tempo, interno Riso. 8.79. Rigenerazione della zampa anteriore in un tritone in un esperimento Riso. 8,80. L'effetto dell'età sull'aumento del numero dei glomeruli del nefrone dopo la rimozione di un rene nei ratti subito dopo la nascita: 1 - curva dell'aumento del numero dei glomeruli nel normale sviluppo postnatale in un rene; 2 - curve di aumento del numero di glomeruli neoformati dopo la rimozione di un rene a diversi stadi di ontogenesi; nella parte rimanente aumenta la proliferazione cellulare (iperplasia) e anche dopo la rimozione di 2/3 del fegato, il peso originale e il volume, ma non la forma, vengono ripristinati. La struttura interna del fegato risulta essere normale, i lobuli hanno una dimensione tipica. Anche la funzionalità epatica ritorna normale. Ipertrofia compensatoria (vicaria). consiste in cambiamenti in uno degli organi con una violazione in un altro, appartenente allo stesso sistema di organi. Un esempio è l’ipertrofia di uno dei reni quando viene rimosso l’altro o l’ingrossamento dei linfonodi quando viene rimossa la milza. I cambiamenti nella capacità di questo tipo di rigenerazione in base all’età sono mostrati in Fig. 8.80 Gli ultimi due metodi differiscono nella sede di rigenerazione, ma i loro meccanismi sono gli stessi: iperplasia e ipertrofia (Fig. 8.81)1. 1 Ipertrofia(Greco iper-+ trofeo— cibo, nutrizione)- un aumento del volume e del peso di un organo del corpo o di una sua singola parte. Iperplasia (greca) iper-+ plasis- formazione, formazione) - un aumento del numero di elementi strutturali dei tessuti attraverso la loro eccessiva nuova formazione. Non si tratta solo della riproduzione cellulare, ma anche di un aumento delle ultrastrutture citoplasmatiche (principalmente mitocondri, miofilamenti, reticolo endoplasmatico, cambiamento dei ribosomi). Riso. 8.81. Diagramma che illustra i meccanismi di ipertrofia e iperplasia: a - normale; b - iperplasia; c - ipertrofia; d - cambio combinato Epitelizzazione Quando si guariscono ferite con copertura epiteliale danneggiata, il processo è più o meno lo stesso, indipendentemente dal fatto che la rigenerazione dell'organo avvenga ulteriormente attraverso l'epimorfosi o meno. La guarigione della ferita epidermica nei mammiferi, quando la superficie della ferita si asciuga fino a formare una crosta, procede come segue (Fig. 8.82). L'epitelio sul bordo della ferita si ispessisce a causa dell'aumento del volume cellulare e dell'espansione degli spazi intercellulari. Il coagulo di fibrina svolge il ruolo di substrato per la migrazione dell'epidermide nella profondità della ferita. Non ci sono mitosi solo nelle cellule epiteliali migranti Riso. 8.82. Schema di alcuni eventi che si verificano durante l'epitelizzazione di una ferita cutanea nei mammiferi: a - inizio della crescita dell'epidermide sotto il tessuto necrotico, b - fusione dell'epidermide e separazione della crosta; 1 - tessuto connettivo; 2 - epidermide; 3 - crosta; 4 - tessuto necrotico; hanno attività fagocitica. Le cellule dei bordi opposti entrano in contatto. Poi avviene la cheratinizzazione dell'epidermide della ferita e la separazione della crosta che ricopre la ferita. Quando l'epidermide dei bordi opposti si incontra nelle cellule situate immediatamente attorno al bordo della ferita, si osserva un'esplosione di mitosi, che poi gradualmente svanisce.Il ripristino dei singoli tessuti mesodermici, come quelli muscolari e scheletrici, viene chiamato rigenerazione dei tessuti. Per la rigenerazione muscolare è importante preservare almeno piccoli monconi su entrambe le estremità e per la rigenerazione ossea è necessario il periostio, quindi esistono molti metodi diversi o tipi di fenomeni morfogenetici per ripristinare le parti del corpo perdute o danneggiate. Le differenze tra loro non sono sempre evidenti ed è necessaria una comprensione più approfondita di questi processi. La rigenerazione non sempre produce una copia esatta della struttura rimossa. Quando tipico rigenerazione, la parte perduta della struttura corretta viene ripristinata (omomorfosi), cosa non succede quando atipico rigenerazione. Un esempio di quest'ultimo è la comparsa di un'altra struttura al posto di quella perduta - eteromorfosi. Potrebbe apparire nel modulo omeotico rigenerazione, che consiste nella comparsa di un'antenna o di un arto al posto dell'occhio negli artropodi. Un'altra opzione - ipomorfosi, rigenerazione con sostituzione parziale della struttura amputata. Ad esempio, una lucertola sviluppa una struttura simile a un punteruolo invece di un arto (Fig. 8.83).La rigenerazione atipica può includere casi cambiamenti di polarità strutture. Pertanto, da un breve frammento di planaria, è possibile ottenere in modo affidabile una planaria bipolare. Si verifica la formazione di strutture aggiuntive o una rigenerazione eccessiva. Dopo un'incisione nel moncone durante l'amputazione della sezione cranica della planaria, si verifica la rigenerazione di due o più teste (Fig. 8.84). Lo studio della rigenerazione riguarda non solo le manifestazioni esterne. Ci sono una serie di aspetti che sono di natura problematica e teorica. Questi includono questioni di regolamentazione e condizioni in cui si verificano i processi di ripristino, questioni relative all'origine delle cellule coinvolte nella rigenerazione, la capacità di rigenerarsi in vari gruppi di animali e le caratteristiche dei processi di ripristino nei mammiferi. È stato stabilito che durante processi di rigenerazione come come determinazione, differenziazione e differenziazione, crescita, morfogenesi Riso. 8.83. Esempi di rigenerazione atipica: a - testa tumorale normale; b - formazione di un'antenna al posto dell'occhio; c - formazione di una struttura a forma di punteruolo al posto di un arto in una salamandra. 1 - occhio; 2 - antenna; 3 - sito di amputazione; 4 - ganglio nervoso Riso. 8.84. Esempi di rigenerazione atipica: a - planaria bipolare; b - planari a più teste ottenuti dopo amputazione della testa e incisioni sulle cultivar, simili ai processi che avvengono nello sviluppo embrionale. I dati finora ottenuti indicano che il restauro delle strutture perdute viene, essenzialmente, effettuato sulla base delle stesse programmi di sviluppo, che guida la loro formazione nell’embrione, e sulla base di meccanismi di sviluppo cellulare e sistemico. Tuttavia, durante la rigenerazione, tutti i processi di sviluppo si ripetono, ad es. in un organismo formato, quindi il ripristino delle strutture presenta una serie di differenze e caratteristiche specifiche. Non c’è dubbio che durante la rigenerazione i meccanismi sistemici – interazioni intercellulari e interbud, regolazione nervosa e umorale – rivestono grande importanza. Pertanto, durante l'epimorfosi dell'arto del tritone, l'epidermide formata durante l'epitelizzazione stimola la lisi dei tessuti mesodermici sottostanti. In sua assenza o quando si forma una cicatrice, la rigenerazione non avviene. Le cellule sotto l'epidermide formata si dedifferenziano e formano un blastema. In questa fase si osservano influenze induttive reciproche tra l'epidermide, che forma il cappuccio ectodermico apicale, e il blastema mesodermico. Durante lo sviluppo embrionale, durante la formazione dell'arto, hanno avuto luogo interazioni simili tra la gemma mesodermica dell'arto e la cresta ectodermica apicale. Durante la dedifferenziazione nelle cellule, viene soppressa l'attività dei geni specifici del tipo che determinano la specializzazione della cellula, ad esempio i geni MRFEMif5nelle fibre muscolari. Vengono quindi attivati i geni necessari per la proliferazione cellulare. Uno di loromsx1. In questa fase, i processi nervosi e l'epidermide che crescono nel blastema producono fattori trofici e di crescita necessari per la proliferazione e la sopravvivenza delle cellule del blastema. Tra questi c'è il fattore di crescita dei fibroblasti FGF-10. Lo stesso fattore è necessario per la proliferazione dell'epidermide stessa. Il blastema, a sua volta, sintetizza in risposta fattori neurotrofici che stimolano la crescita dei nervi. I nervi sono necessari per formare il cappuccio ectodermico apicale. Oltre a questo si produce il blastema, come il cappuccio epidermico apicale FGF-8,che stimola la crescita capillare. Vale la pena notare le differenze osservate in questa fase tra rigenerazione e sviluppo embrionale. Per implementare la rigenerazione è necessaria l'innervazione. Senza di essa può verificarsi la dedifferenziazione cellulare, ma il successivo sviluppo è assente. Durante il periodo della morfogenesi embrionale dell'arto (durante la differenziazione cellulare), i nervi non sono ancora formati. Oltre all'innervazione, nella fase iniziale della rigenerazione è necessaria l'azione degli enzimi metalloproteinasi. Distruggono i componenti della matrice, consentendo alle cellule di dividersi (dissociarsi) e proliferare attivamente. Le cellule in contatto tra loro non possono continuare la rigenerazione e rispondere all'azione dei fattori di crescita. Pertanto, durante la rigenerazione, si osservano tutte le varianti delle interazioni intercellulari: attraverso il rilascio di fattori paracrini che si diffondono da una cellula all'altra, l'interazione attraverso la matrice e attraverso il contatto diretto delle superfici cellulari. Durante la fase di dedifferenziazione, i geni omeotici sono espressi nelle cellule monconeHoxD8EHoxDlO,e con l'inizio della differenziazione: i geniHoxD9EHoxD13.Come mostrato nella sezione 8.3.4, questi stessi geni sono attivamente trascritti nella morfogenesi embrionale dell'arto.È importante notare che durante la rigenerazione la differenziazione cellulare viene persa, ma la loro determinazione viene preservata. Già nella fase del blastema indifferenziato vengono stabilite le caratteristiche principali dell'arto rigenerante. Ciò non richiede l'attivazione dei geni che forniscono la specificazione degli arti (Tbx-5per anteriore eTBX-4 per la parte posteriore). L'arto si forma a seconda della posizione del blastema. Il suo sviluppo avviene allo stesso modo dell'embriogenesi: prima le sezioni prossimali e poi quelle distali. Il gradiente prossimale-distale che determina quali parti della gemma in crescita diventeranno una spalla, quale diventerà un avambraccio e quale diventerà una mano è determinato dal gradiente proteico Prodotto 1.È localizzato sulla superficie delle cellule del blastema e la sua concentrazione è maggiore alla base dell'arto. Questa proteina svolge il ruolo di un recettore e la sua molecola segnale (ligando) è una proteina nAG.È sintetizzato dalle cellule di Schwann che circondano il nervo rigenerante. In assenza di questa proteina, che attraverso l'interazione ligando-recettore innesca l'attivazione della cascata di geni necessari allo sviluppo, la rigenerazione non avviene. Ciò spiega il fenomeno del mancato ripristino dell'arto quando un nervo viene tagliato, così come quando un numero insufficiente di fibre nervose cresce nel blastema. È interessante notare che se il nervo dell'arto di un tritone viene retratto sotto la pelle della base dell'arto, si forma un arto aggiuntivo. Se viene portato alla base della coda, viene stimolata la formazione di una coda aggiuntiva. La riduzione del nervo nella regione laterale non provoca strutture aggiuntive. Tutto ciò ha portato alla creazione del concetto campi di rigenerazione. Riso. 8,85. Esperimento con la rotazione del blastema dell'arto (spiegazioni nel testo) Similmente al processo dell'embriogenesi, anche l'asse antero-posteriore si forma nell'area dell'arto in via di sviluppo. Nel rudimento in via di sviluppo appare una zona di attività polarizzante, che determina l'asimmetria dell'arto. Ruotando di 180° l'estremità del moncone dell'arto si ottiene un arto con sdoppiamento speculare delle dita (Fig. 8.85), è vero quindi che la formazione dell'arto avviene nel campo dell'organo e il blastema è un sistema di autoregolamentazione. Oltre a quanto sopra, la prova di ciò è fornita dai risultati ottenuti in una serie di esperimenti sul trapianto del blastema dell'arto anteriore nel blastema della metà della coscia (Fig. 8.86). Quando trapiantato nel campo di rigenerazione di un altro arto, l'innesto viene posizionato in base alle informazioni posizionali ricevute (gradienti della sostanza): il blastema della spalla viene spostato al centro della coscia, l'avambraccio - alla parte inferiore della gamba, al polso - alla zampa. Lo sviluppo del blastema trapiantato nella parte corrispondente dell'arto anteriore avviene in base alla sua determinazione, che è determinata dal livello di amputazione. Oltre alle interazioni intercellulari e induttive, che risultano essere meno diversificate rispetto alla morfogenesi embrionale, la rigenerazione è significativamente influenzato dalla regolazione nervosa e umorale. Ciò è abbastanza comprensibile dal fatto che la rigenerazione avviene in un organismo già formato, dove i principali meccanismi regolatori sono questi ultimi. Tra gli influssi umorali è da segnalare l'azione degli ormoni. L'aldosterone, gli ormoni tiroidei e ipofisari hanno un effetto stimolante sul ripristino dei valori perduti Riso. 8.86. Esperimenti sul trapianto del blastema dell'arto anteriore nel campo delle strutture posteriori (spiegazioni nel testo). I metaboliti rilasciati dal tessuto danneggiato e trasportati dal plasma sanguigno o trasmessi attraverso il fluido intercellulare hanno un effetto simile. Questo è il motivo per cui in alcuni casi ulteriori danni accelerano il processo di rigenerazione. Oltre a quanto sopra, la rigenerazione è influenzata anche da altri fattori, tra cui la temperatura alla quale avviene il recupero, l'età dell'animale, il funzionamento dell'organo che stimola la rigenerazione e, in alcune situazioni, una variazione della carica elettrica nell'animale. rigenerare. È stato stabilito che i veri cambiamenti nell'attività elettrica si verificano negli arti degli anfibi dopo l'amputazione e durante il processo di rigenerazione. Quando una corrente elettrica viene fatta passare attraverso un arto amputato, le rane artigliate adulte mostrano una maggiore rigenerazione degli arti anteriori. Nei rigenerati aumenta la quantità di tessuto nervoso, da cui si conclude che la corrente elettrica stimola la crescita dei nervi nei bordi degli arti, che normalmente non si rigenerano. I tentativi di stimolare la rigenerazione degli arti nei mammiferi in modo simile non hanno avuto successo. Sotto l'influenza di una corrente elettrica o combinando l'azione di una corrente elettrica con un fattore di crescita nervoso, è stato possibile ottenere nei ratti solo la crescita del tessuto scheletrico sotto forma di calli cartilaginei e ossei, che non somigliavano agli elementi normali dello scheletro degli arti. Uno degli aspetti più intriganti della teoria della rigenerazione è la questione delle sue fonti cellulari. Da dove provengono o come nascono le cellule di blastema indifferenziate, morfologicamente simili alle cellule mesenchimali? Al momento ce ne sono tre possibilifonti di rigenerazione.Il primo ècellule dedifferenziatesecondo -cellule staminali regionalie il terzo -cellule staminali provenienti da altre strutture,migrato nel luogo di rigenerazione. La maggior parte dei ricercatori riconosce la dedifferenziazione e la metaplasia durante la rigenerazione del cristallino negli anfibi. Il significato teorico di questo problema risiede nel presupposto della possibilità o impossibilità che una cellula cambi il suo programma a tal punto da ritornare ad uno stato in cui è nuovamente in grado di dividere e riprogrammare il suo apparato sintetico. La presenza di cellule staminali regionali è ormai accertata in molti tessuti: muscoli, ossa, epidermide cutanea, fegato, retina e altri. Tali cellule si trovano anche nel tessuto nervoso, in alcune aree del cervello. In molti casi si ritiene che siano la fonte da cui si formano cellule differenziate durante la rigenerazione (medicina rigenerativa, medicina veterinaria rigenerativa). Si presuppone che all’aumentare dell’età di un individuo, la popolazione di cellule staminali regionali diminuisca. Se un organo è privo di cellule staminali regionali, le cellule di altri organi possono migrare al suo interno e dare origine al tessuto desiderato. Recentemente è stato dimostrato che le cellule staminali isolate da un tessuto adulto possono dare origine a cellule mature di altri lignaggi cellulari, indipendentemente dallo scopo dello strato germinale classico. Pertanto, l'endotelio delle grandi arterie principali non dispone di riserve proprie di cellule staminali. Il suo rinnovamento avviene grazie all'ingresso nel flusso sanguigno delle cellule staminali del midollo osseo. Tuttavia, l'inefficacia comparativa di tali trasformazioni in vivo(nel corpo), anche in presenza di danni tissutali, solleva la questione se questo meccanismo abbia un significato fisiologico. È interessante notare che, tra le cellule staminali adulte, la capacità di cambiare lignaggio è maggiore nelle cellule staminali che possono essere coltivate nel mezzo per Per molto tempo Se il problema della trasformazione delle linee cellulari può essere risolto, allora sarà del tutto possibile utilizzare queste tecnologie nella medicina riparativa per trattare un'ampia gamma di malattie. Tuttavia, nonostante le conquiste della biologia negli ultimi anni, ci sono ancora molte questioni irrisolte nel problema della rigenerazione.
La rigenerazione (in patologia) è il ripristino dell'integrità dei tessuti danneggiati da qualsiasi processo patologico o influenza traumatica esterna. Il recupero avviene grazie alle cellule vicine, riempiendo il difetto con cellule giovani e la loro successiva trasformazione in tessuto maturo. Questa forma è chiamata rigenerazione riparativa (compensativa). In questo caso sono possibili due opzioni di rigenerazione: 1) la perdita viene compensata con tessuto dello stesso tipo di quello morto (rigenerazione completa); 2) la perdita viene sostituita da tessuto connettivo giovane (granulazione), che si trasforma in tessuto cicatrizzato (rigenerazione incompleta), che non è una rigenerazione in senso proprio, ma la guarigione di un difetto tissutale.
La rigenerazione è preceduta dal rilascio di una determinata area dalle cellule morte mediante fusione enzimatica e assorbimento nella linfa o nel sangue o mediante (vedi). I prodotti di fusione sono uno degli stimolatori della proliferazione delle cellule vicine. In molti organi e sistemi esistono aree le cui cellule sono fonte di proliferazione cellulare durante la rigenerazione. Ad esempio, nel sistema scheletrico, tale fonte è il periostio, le cui cellule, moltiplicandosi, formano prima il tessuto osteoide, che successivamente si trasforma in osso; nelle mucose - cellule delle ghiandole profonde (cripte). La rigenerazione delle cellule del sangue avviene nel midollo osseo e al di fuori di esso nel sistema e nei suoi derivati (linfonodi, milza).
Non tutti i tessuti hanno la capacità di rigenerarsi, e non nella stessa misura. Pertanto, le cellule muscolari del cuore non sono in grado di riprodursi, con conseguente formazione di fibre muscolari mature, pertanto qualsiasi difetto nei muscoli miocardici viene sostituito da una cicatrice (in particolare dopo un infarto). Quando il tessuto cerebrale muore (dopo emorragia, rammollimento arteriosclerotico), il difetto non viene sostituito dal tessuto nervoso, ma si forma un tessuto.
A volte il tessuto che appare durante la rigenerazione differisce nella struttura dall'originale (rigenerazione atipica) o il suo volume supera il volume del tessuto morto (iperrigenerazione). Questo corso del processo di rigenerazione può portare alla crescita del tumore.
Rigenerazione (latino rigenerare - rinascita, restauro) - ripristino dell'integrità anatomica di un organo o tessuto dopo la morte di elementi strutturali.
In condizioni fisiologiche, i processi di rigenerazione avvengono continuamente con intensità variabile nei diversi organi e tessuti, a seconda dell'intensità dell'invecchiamento degli elementi cellulari di un dato organo o tessuto e della loro sostituzione con elementi di nuova formazione. Gli elementi formati del sangue, le cellule dell'epitelio tegumentario della pelle, le mucose del tratto gastrointestinale e del tratto respiratorio vengono continuamente sostituiti. I processi ciclici nel sistema riproduttivo femminile portano al rigetto ritmico e al rinnovamento dell'endometrio attraverso la sua rigenerazione.
Tutti questi processi sono il prototipo fisiologico della rigenerazione patologica (detta anche riparativa). Le caratteristiche dello sviluppo, del decorso e dell'esito della rigenerazione riparativa sono determinati dall'entità della morte dei tessuti e dalla natura delle influenze patogene. Quest'ultima circostanza deve essere tenuta particolarmente presente, poiché le condizioni e le cause della morte dei tessuti sono essenziali per il processo di rigenerazione e i suoi esiti. Ad esempio, le cicatrici dopo le ustioni cutanee hanno un carattere speciale, diverso dalle cicatrici di altra origine; le cicatrici sifilitiche sono ruvide, portano a retrazioni profonde e deturpazione dell'organo, ecc. A differenza della rigenerazione fisiologica, la rigenerazione riparativa copre una vasta gamma di processi che portano alla compensazione del difetto causato dalla perdita di tessuto a causa del suo danno. Si distingue tra rigenerazione riparativa completa - restituzione (sostituzione del difetto con tessuto dello stesso tipo e della stessa struttura di quello morto) e rigenerazione riparativa incompleta (riempimento del difetto con tessuto che ha proprietà plastiche maggiori di quello morto, cioè tessuto di granulazione ordinario e tessuto connettivo con ulteriore trasformazione in tessuto cicatriziale). Pertanto, in patologia, rigenerazione spesso significa guarigione.
Il concetto di rigenerazione è anche associato al concetto di organizzazione, poiché entrambi i processi si basano sulle leggi generali della formazione di nuovi tessuti e sul concetto di sostituzione, cioè spostamento e sostituzione del tessuto preesistente con tessuto neoformato (ad esempio, sostituzione di un coagulo sanguigno con tessuto fibroso).
Il grado di completezza della rigenerazione è determinato da due fattori principali: 1) il potenziale rigenerativo di un dato tessuto; 2) il volume del difetto e la stessa o eterogenea specie di tessuto morto.
Il primo fattore è spesso associato al grado di differenziazione di un dato tessuto. Tuttavia, il concetto stesso di differenziazione e il contenuto di questo concetto sono molto relativi, e il confronto dei tessuti su questa base con la determinazione di una gradazione quantitativa di differenziazione in termini funzionali e morfologici è impossibile. Insieme ai tessuti che hanno un elevato potenziale rigenerativo (ad esempio tessuto epatico, mucose del tratto gastrointestinale, organi emopoietici, ecc.), Esistono organi con un potenziale di rigenerazione insignificante, in cui la rigenerazione non termina mai con il completo ripristino del perduto tessuto (ad esempio miocardio, sistema nervoso centrale). Il tessuto connettivo, gli elementi della parete dei più piccoli vasi sanguigni e linfatici, i nervi periferici, il tessuto reticolare e i suoi derivati hanno una plasticità estremamente elevata. Pertanto, l'irritazione plastica, che è un trauma nel senso ampio del termine (cioè tutte le sue forme), stimola innanzitutto la crescita di questi tessuti.
Il volume del tessuto morto è essenziale per la completezza della rigenerazione, ed i limiti quantitativi di perdita tissutale per ciascun organo, che determinano il grado di ripristino, sono più o meno conosciuti empiricamente. Si ritiene che per la completezza della rigenerazione sia importante non solo il volume come categoria puramente quantitativa, ma anche la complessa diversità dei tessuti morti (questo vale soprattutto per la morte dei tessuti causata da effetti tossico-infettivi). Per spiegare questo fatto, si dovrebbe, a quanto pare, rivolgersi agli schemi generali di stimolazione dei processi plastici in condizioni patologiche: gli stimolatori sono i prodotti della morte dei tessuti stessi (ipotetici “necroormoni”, “raggi mitogenetici”, “trefoni”, ecc. ). Alcuni di essi sono stimolatori specifici per cellule di un certo tipo, altri sono aspecifici e stimolano i tessuti più plastici. Gli stimolanti non specifici includono prodotti della degradazione e dell'attività vitale dei leucociti. La loro presenza durante l'infiammazione reattiva, che si sviluppa sempre con la morte non solo degli elementi parenchimali, ma anche dello stroma vascolare, favorisce la proliferazione degli elementi più plastici: il tessuto connettivo, cioè l'eventuale sviluppo di una cicatrice.
Esiste uno schema generale per la sequenza dei processi di rigenerazione, indipendentemente dall'area in cui avviene. In condizioni patologiche i processi di rigenerazione nel senso stretto del termine e i processi di guarigione sono di natura diversa. Questa differenza è determinata dalla natura della morte dei tessuti e dalla direzione d'azione selettiva del fattore patogeno. Forme pure di rigenerazione, cioè ripristino di tessuto identico a quello perduto, si osservano nei casi in cui solo specifici elementi parenchimali di un organo muoiono sotto l'influenza dell'influenza patogena, a condizione che abbiano un'elevata potenza rigenerativa. Un esempio di ciò è la rigenerazione dell'epitelio tubulare renale selettivamente danneggiato dall'esposizione tossica; rigenerazione dell'epitelio delle mucose durante la desquamazione; rigenerazione degli alveolociti polmonari nel catarro desquamativo; rigenerazione dell'epitelio cutaneo; rigenerazione dell'endotelio dei vasi sanguigni e dell'endocardio, ecc. In questi casi, la fonte della rigenerazione sono i restanti elementi cellulari, la cui riproduzione, maturazione e differenziazione porta alla completa sostituzione degli elementi parenchimali perduti. Quando muoiono complessi strutturali complessi, il ripristino del tessuto perduto avviene da aree speciali dell'organo, che sono centri di rigenerazione unici. Nella mucosa intestinale, nell'endometrio, tali centri sono cripte ghiandolari. Le loro cellule moltiplicandosi ricoprono dapprima il difetto con uno strato di cellule indifferenziate, da cui poi si differenziano le ghiandole e viene ripristinata la struttura della mucosa. Nel sistema scheletrico, tale centro di rigenerazione è il periostio, nell'epitelio squamoso tegumentario - lo strato malpighiano, nel sistema sanguigno - midollo osseo e derivati extramidollari del tessuto reticolare.
La legge generale della rigenerazione è la legge dello sviluppo, secondo la quale, nel processo di neoplasia, nascono giovani derivati cellulari indifferenziati, che successivamente subiscono stadi di differenziazione morfologica e funzionale fino alla formazione di tessuto maturo.
La morte di aree di un organo costituito da un complesso di vari tessuti provoca un'infiammazione reattiva (vedi) lungo la periferia. Questo è un atto adattativo, poiché la reazione infiammatoria è accompagnata da iperemia e aumento del metabolismo dei tessuti, che favorisce la crescita delle cellule neoformate. Inoltre, gli elementi cellulari infiammatori del gruppo degli istofagociti sono materiale plastico per la formazione del tessuto connettivo.
In patologia, la guarigione anatomica viene spesso ottenuta con l'aiuto del tessuto di granulazione (vedi) - lo stadio della nuova formazione di una cicatrice fibrosa. Il tessuto di granulazione si sviluppa durante quasi ogni rigenerazione riparativa, ma il grado del suo sviluppo e i risultati finali variano entro limiti molto ampi. A volte si tratta di aree tenere di tessuto fibroso difficili da distinguere all'esame microscopico, a volte si tratta di filamenti grossolani e densi di tessuto cicatriziale braditrofico ialinizzato, spesso soggetti a calcificazione (vedi) e ossificazione.
Oltre al potenziale rigenerativo di un dato tessuto, nel processo di rigenerazione sono importanti la natura del suo danno, il suo volume e fattori generali. Questi includono l'età del soggetto, la natura e le caratteristiche della nutrizione e la reattività generale del corpo. In caso di disturbi di innervazione o carenze vitaminiche, il normale corso della rigenerazione riparativa viene distorto, il che si esprime molto spesso in un rallentamento del processo di rigenerazione e in una lentezza delle reazioni cellulari. Esiste anche il concetto di diatesi fibroplastica come caratteristica costituzionale del corpo per rispondere a varie irritazioni patogene con una maggiore formazione di tessuto fibroso, che si manifesta con la formazione di cheloidi (vedi), malattia adesiva. Nella pratica clinica è importante tenere conto dei fattori generali per creare le condizioni ottimali per la completezza del processo di rigenerazione e guarigione.
La rigenerazione è uno dei processi adattivi più importanti che garantiscono il ripristino della salute e la continuazione della vita in circostanze di emergenza create dalla malattia. Tuttavia, come ogni processo adattivo, la rigenerazione ad un certo stadio e lungo determinati percorsi di sviluppo può perdere il suo significato adattivo e creare essa stessa nuove forme di patologia. Cicatrici deturpanti che deformano un organo e ne compromettono gravemente la funzione (ad esempio, trasformazione cicatriziale delle valvole cardiache a seguito di endocardite) creano spesso una grave patologia cronica che richiede misure terapeutiche speciali. A volte il tessuto neoformato supera quantitativamente il volume del tessuto morto (superrigenerazione). Inoltre, in ogni rigenerato ci sono elementi di atipia, la cui grave gravità è uno stadio di sviluppo del tumore (vedi). Rigenerazione di singoli organi e tessuti: vedere gli articoli pertinenti su organi e tessuti.
informazioni generali
Rigenerazione(dal lat. rigenerazione - rinascita) - ripristino (sostituzione) di elementi strutturali di tessuto per sostituire i morti. In senso biologico, la rigenerazione lo è processo adattivo sviluppato durante l'evoluzione e insito in tutti gli esseri viventi. Nella vita di un organismo, ogni funzione funzionale richiede il dispendio di un substrato materiale e il suo ripristino. Pertanto, durante la rigenerazione c'è autoriproduzione della materia vivente, Inoltre, questa auto-riproduzione dei viventi riflette principio di autoregolamentazione E automazione delle funzioni vitali(Davydovsky I.V., 1969).
Il ripristino rigenerativo della struttura può avvenire a diversi livelli: molecolare, subcellulare, cellulare, tissutale e di organo, ma parliamo sempre della sostituzione di una struttura in grado di svolgere una funzione specializzata. La rigenerazione è ripristino sia della struttura che della funzione. L'importanza del processo rigenerativo risiede nel supporto materiale dell'omeostasi.
Il ripristino della struttura e della funzione può essere effettuato utilizzando processi iperplastici cellulari o intracellulari. Su questa base si distinguono le forme di rigenerazione cellulare e intracellulare (Sarkisov D.S., 1977). Per forma cellulare la rigenerazione è caratterizzata dalla riproduzione cellulare in modo mitotico e amitotico, per forma intracellulare, che può essere organoide e intraorganoide - aumento del numero (iperplasia) e delle dimensioni (ipertrofia) delle ultrastrutture (nuclei, nucleoli, mitocondri, ribosomi, complesso lamellare, ecc.) e dei loro componenti (vedi Fig. 5, 11, 15) . Forma intracellulare la rigenerazione è universale, poiché è caratteristico di tutti gli organi e tessuti. Tuttavia, la specializzazione strutturale e funzionale di organi e tessuti nella filo- e ontogenesi ha “selezionato” per alcuni la forma prevalentemente cellulare, per altri - prevalentemente o esclusivamente intracellulare, per altri - entrambe le forme di rigenerazione allo stesso modo (Tabella 5). La predominanza dell'una o dell'altra forma di rigenerazione in determinati organi e tessuti è determinata dal loro scopo funzionale, dalla specializzazione strutturale e funzionale. La necessità di preservare l'integrità del tegumento del corpo spiega, ad esempio, la predominanza della forma cellulare di rigenerazione dell'epitelio sia della pelle che delle mucose. Funzione specializzata della cellula piramidale del cervello
cervello, così come la cellula muscolare del cuore, esclude la possibilità di divisione di queste cellule e consente di comprendere la necessità di selezione nella filo- e ontogenesi della rigenerazione intracellulare come unica forma di ripristino di questo substrato.
Tabella 5. Forme di rigenerazione negli organi e nei tessuti dei mammiferi (secondo Sarkisov D.S., 1988)
Questi dati confutano le idee esistenti fino a tempi recenti sulla perdita della capacità di rigenerazione di alcuni organi e tessuti dei mammiferi, sulla rigenerazione “male” e “bene” dei tessuti umani, e sull’idea che esista una “legge della relazione inversa” tra i grado di differenziazione dei tessuti e la loro capacità di rigenerarsi. È ormai accertato che nel corso dell'evoluzione la capacità di rigenerarsi in alcuni tessuti e organi non è scomparsa, ma ha assunto forme (cellulari o intracellulari) corrispondenti alla loro originalità strutturale e funzionale (Sarkisov D.S., 1977). Pertanto, tutti i tessuti e gli organi hanno la capacità di rigenerarsi; solo le sue forme differiscono a seconda della specializzazione strutturale e funzionale del tessuto o dell'organo.
Morfogenesi Il processo rigenerativo consiste di due fasi: proliferazione e differenziazione. Queste fasi sono particolarmente ben espresse nella forma cellulare di rigenerazione. IN fase di proliferazione le cellule giovani e indifferenziate si moltiplicano. Queste cellule sono chiamate cambiale(dal lat. cambio- scambiare, cambiare), cellule staminali E cellule progenitrici.
Ogni tessuto è caratterizzato dalle proprie cellule cambiali, che differiscono nel grado di attività proliferativa e specializzazione, tuttavia, una cellula staminale può essere l'antenato di diverse specie
cellule (ad esempio cellule staminali del sistema ematopoietico, tessuto linfoide, alcuni rappresentanti cellulari del tessuto connettivo).
IN fase di differenziazione le cellule giovani maturano e avviene la loro specializzazione strutturale e funzionale. Lo stesso cambiamento dall'iperplasia delle ultrastrutture alla loro differenziazione (maturazione) è alla base del meccanismo di rigenerazione intracellulare.
Regolazione del processo rigenerativo. I meccanismi di regolazione della rigenerazione includono umorale, immunologico, nervoso e funzionale.
Meccanismi umorali sono implementati sia nelle cellule di organi e tessuti danneggiati (regolatori intratessuti e intracellulari) che all'esterno di essi (ormoni, poetine, mediatori, fattori di crescita, ecc.). I regolatori umorali includono Keylon (dal greco chalaino- indebolire) - sostanze che possono sopprimere la divisione cellulare e la sintesi del DNA; sono tessuto-specifici. Meccanismi immunologici le regolazioni sono associate alle “informazioni rigenerative” trasportate dai linfociti. A questo proposito va notato che i meccanismi dell’omeostasi immunologica determinano anche l’omeostasi strutturale. Meccanismi nervosi i processi rigenerativi sono associati principalmente alla funzione trofica del sistema nervoso e meccanismi funzionali- con la “richiesta” funzionale di un organo o tessuto, considerata come stimolo alla rigenerazione.
Lo sviluppo del processo rigenerativo dipende in gran parte da una serie di condizioni o fattori generali e locali. A generale dovrebbero includere età, costituzione, stato nutrizionale, stato metabolico ed emopoietico, Locale - lo stato di innervazione, circolazione sanguigna e linfatica del tessuto, l'attività proliferativa delle sue cellule, la natura del processo patologico.
Classificazione. Esistono tre tipi di rigenerazione: fisiologica, riparativa e patologica.
Rigenerazione fisiologica avviene durante tutta la vita ed è caratterizzata da un costante rinnovamento delle cellule, delle strutture fibrose e della sostanza base del tessuto connettivo. Non esistono strutture che non subiscono una rigenerazione fisiologica. Dove domina la forma di rigenerazione cellulare, avviene il rinnovamento cellulare. In questo modo si verifica un cambiamento costante dell'epitelio tegumentario della pelle e delle mucose, dell'epitelio secretorio delle ghiandole esocrine, delle cellule che rivestono le membrane sierose e sinoviali, degli elementi cellulari del tessuto connettivo, dei globuli rossi, dei leucociti e delle piastrine, eccetera. Nei tessuti e negli organi dove si perde la forma cellulare di rigenerazione, ad esempio nel cuore, nel cervello, si rinnovano le strutture intracellulari. Insieme al rinnovamento delle cellule e delle strutture subcellulari, rigenerazione biochimica, quelli. rinnovamento della composizione molecolare di tutti i componenti del corpo.
Rigenerazione riparativa o riparativa osservato in vari processi patologici che portano a danni a cellule e tessuti
suo. I meccanismi di rigenerazione riparativa e fisiologica sono gli stessi; la rigenerazione riparativa è una rigenerazione fisiologica potenziata. Tuttavia, poiché la rigenerazione riparativa è stimolata da processi patologici, presenta differenze morfologiche qualitative rispetto a quelle fisiologiche. La rigenerazione riparativa può essere completa o incompleta.
Rigenerazione completa, O restituzione, caratterizzato dalla compensazione del difetto con tessuto identico a quello morto. Si sviluppa prevalentemente nei tessuti dove prevale la rigenerazione cellulare. Pertanto, nel tessuto connettivo, nelle ossa, nella pelle e nelle mucose, anche i difetti d'organo relativamente grandi possono essere sostituiti dalla divisione cellulare con tessuto identico a quello morto. A rigenerazione incompleta, O sostituzione, il difetto è sostituito da tessuto connettivo, cicatrice. La sostituzione è caratteristica degli organi e dei tessuti in cui predomina la forma di rigenerazione intracellulare o è combinata con la rigenerazione cellulare. Poiché la rigenerazione implica il ripristino di una struttura in grado di svolgere una funzione specializzata, il significato di rigenerazione incompleta non sta nel sostituire il difetto con una cicatrice, ma nel iperplasia compensatoria elementi del restante tessuto specializzato, la cui massa aumenta, vale a dire sta succedendo ipertrofia tessuti.
A rigenerazione incompleta, quelli. guarigione del tessuto con una cicatrice, l'ipertrofia avviene come espressione del processo rigenerativo, motivo per cui viene chiamata rigenerativo, contiene il significato biologico di rigenerazione riparativa. L'ipertrofia rigenerativa può essere effettuata in due modi: attraverso l'iperplasia cellulare o l'iperplasia e l'ipertrofia delle ultrastrutture cellulari, ad es. ipertrofia cellulare.
Ripristino della massa originaria dell'organo e della sua funzione dovuta principalmente a iperplasia cellulare si verifica durante l'ipertrofia rigenerativa del fegato, dei reni, del pancreas, delle ghiandole surrenali, dei polmoni, della milza, ecc. Ipertrofia rigenerativa dovuta a iperplasia delle ultrastrutture cellulari caratteristico del miocardio, del cervello, cioè quegli organi in cui predomina la forma di rigenerazione intracellulare. Nel miocardio, ad esempio, lungo la periferia della cicatrice che ha sostituito l'infarto, la dimensione delle fibre muscolari aumenta in modo significativo, cioè si ipertrofizzano per iperplasia dei loro elementi subcellulari (Fig. 81). Entrambi i percorsi dell'ipertrofia rigenerativa non si escludono a vicenda, ma, al contrario, spesso combinare. Pertanto, con l'ipertrofia rigenerativa del fegato, non solo si verifica un aumento del numero di cellule nella parte dell'organo preservata dopo il danno, ma anche la loro ipertrofia, causata dall'iperplasia delle ultrastrutture. Non si può escludere che nel muscolo cardiaco l'ipertrofia rigenerativa possa avvenire non solo sotto forma di ipertrofia delle fibre, ma anche aumentando il numero di cellule muscolari che le compongono.
Il periodo di recupero di solito non si limita solo al fatto che la rigenerazione riparativa si svolge nell'organo danneggiato. Se
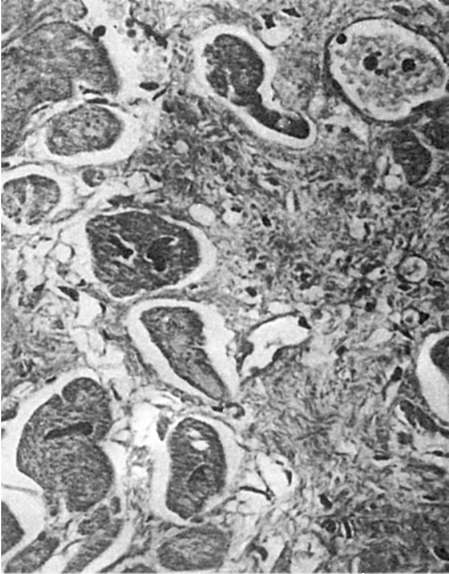 Riso. 81. Ipertrofia miocardica rigenerativa. Le fibre muscolari ipertrofiche si trovano lungo la periferia della cicatrice
Riso. 81. Ipertrofia miocardica rigenerativa. Le fibre muscolari ipertrofiche si trovano lungo la periferia della cicatrice
l'influenza del fattore patogeno cessa fino alla morte cellulare e si verifica il graduale ripristino degli organelli danneggiati. Di conseguenza, le manifestazioni della reazione riparativa dovrebbero essere ampliate per includere processi intracellulari riparativi negli organi distroficamente alterati. L'opinione generalmente accettata sulla rigenerazione solo come fase finale del processo patologico è ingiustificata. La rigenerazione riparativa no Locale, UN reazione generale del corpo, coprendo vari organi, ma realizzandosi pienamente solo nell'uno o nell'altro di essi.
DI rigenerazione patologica dicono nei casi in cui, in conseguenza di determinati motivi, ci sia distorsione del processo rigenerativo, interruzione dei cambiamenti di fase proliferazione
e differenziazione. La rigenerazione patologica si manifesta nella formazione eccessiva o insufficiente di tessuto rigenerante (iper- O iporigenerazione), così come nella trasformazione durante la rigenerazione di un tipo di tessuto in un altro [metaplasia - vedi. Processi di aggiustamento (adattamento) e compensazione]. Gli esempi includono l'iperproduzione di tessuto connettivo con la formazione cheloide, eccessiva rigenerazione dei nervi periferici e formazione eccessiva di callo durante la guarigione delle fratture, guarigione lenta delle ferite e metaplasia epiteliale nel focolaio dell'infiammazione cronica. La rigenerazione patologica di solito si sviluppa quando violazioni generali E condizioni di rigenerazione locale(innervazione compromessa, carenza di proteine e vitamine, infiammazione cronica, ecc.).
Rigenerazione di singoli tessuti e organi
La rigenerazione riparativa del sangue differisce dalla rigenerazione fisiologica principalmente per la sua maggiore intensità. In questo caso, nelle ossa lunghe appare il midollo osseo rosso attivo al posto del midollo osseo grasso (trasformazione mieloide del midollo osseo grasso). Le cellule di grasso vengono sostituite da isole in crescita di tessuto ematopoietico, che riempie il canale midollare e appare succoso e rosso scuro. Inoltre, l'emopoiesi inizia a verificarsi al di fuori del midollo osseo - extramidollare, O extramidollare, emopoiesi. Ocha-
gi di emopoiesi extramidollare (eterotopica) a seguito dell'espulsione delle cellule staminali dal midollo osseo compaiono in molti organi e tessuti: milza, fegato, linfonodi, membrane mucose, tessuto adiposo, ecc.
La rigenerazione del sangue può essere fortemente depresso (ad esempio, con malattia da radiazioni, anemia aplastica, aleuchia, agranulocitosi) o pervertito (ad esempio, con anemia perniciosa, policitemia, leucemia). In questo caso, elementi formati immaturi, funzionalmente inferiori e che si deteriorano rapidamente entrano nel sangue. In questi casi si parla rigenerazione patologica del sangue.
Le capacità riparative degli organi dei sistemi ematopoietico e immunocompetente sono ambigue. Midollo osseo ha proprietà plastiche molto elevate e può essere ripristinato anche con danni significativi. I linfonodi rigenerarsi bene solo nei casi in cui sono preservate le connessioni dei vasi linfatici afferenti ed efferenti con il tessuto connettivo circostante. Rigenerazione dei tessuti milza quando danneggiato, di solito è incompleto; il tessuto morto è sostituito da una cicatrice.
Rigenerazione dei vasi sanguigni e linfatici procede in modo ambiguo a seconda del loro calibro.
Microvasi hanno una maggiore capacità di rigenerarsi rispetto ai grandi vasi. La nuova formazione di microvasi può avvenire per gemmazione o autogena. Durante la rigenerazione vascolare per gemmazione (Fig. 82) nella loro parete compaiono protuberanze laterali dovute alla rapida divisione delle cellule endoteliali (angioblasti). Si formano filamenti di endotelio, in cui compaiono degli spazi vuoti e il sangue o la linfa fluiscono al loro interno dal vaso “materno”. Altri elementi: la parete vascolare si forma grazie alla differenziazione dell'endotelio e delle cellule del tessuto connettivo che circondano il vaso, nella parete vascolare si sviluppano fibre nervose provenienti da nervi preesistenti. Neoplasie autogene vasi è che nel tessuto connettivo compaiono focolai di cellule indifferenziate. In questi focolai compaiono delle fessure nelle quali si aprono i capillari preesistenti e fuoriesce il sangue. Le giovani cellule del tessuto connettivo, differenziandosi, formano il rivestimento endoteliale e altri elementi della parete vascolare.
 Riso. 82. Rigenerazione vascolare per gemmazione
Riso. 82. Rigenerazione vascolare per gemmazione
Grandi navi non hanno proprietà plastiche sufficienti. Pertanto, se le loro pareti vengono danneggiate, vengono ripristinate solo le strutture della conchiglia interna, il suo rivestimento endoteliale; gli elementi delle membrane media ed esterna vengono solitamente sostituiti dal tessuto connettivo, che spesso porta al restringimento o all'obliterazione del lume del vaso.
Rigenerazione del tessuto connettivo inizia con la proliferazione di giovani elementi mesenchimali e la nuova formazione di microvasi. Si forma un tessuto connettivo giovane, ricco di cellule e vasi a pareti sottili, che ha un aspetto caratteristico. Questo è un succoso tessuto rosso scuro con una superficie granulare, come se fosse cosparso di grossi granuli, che era la base per chiamarlo tessuto di granulazione. I granuli sono anse di vasi a pareti sottili appena formati che sporgono sopra la superficie e costituiscono la base del tessuto di granulazione. Tra i vasi sono presenti numerose cellule del tessuto connettivo simili a linfociti indifferenziati, leucociti, plasmacellule e mastociti (Fig. 83). Quello che succede dopo è maturazione tessuto di granulazione, che si basa sulla differenziazione di elementi cellulari, strutture fibrose e vasi sanguigni. Il numero di elementi ematogeni diminuisce e aumentano i fibroblasti. In connessione con la sintesi del collagene da parte dei fibroblasti, argirofilo(vedi Fig. 83), e poi fibre di collagene. La sintesi dei glicosaminoglicani da parte dei fibroblasti serve alla formazione
sostanza principale tessuto connettivo. Man mano che i fibroblasti maturano, il numero delle fibre di collagene aumenta e queste si raggruppano in fasci; Allo stesso tempo, il numero di vasi diminuisce, si differenziano in arterie e vene. La maturazione del tessuto di granulazione termina con la formazione tessuto cicatriziale fibroso grossolano.
La nuova formazione del tessuto connettivo avviene non solo quando è danneggiato, ma anche quando altri tessuti non vengono completamente rigenerati, così come durante l'organizzazione (incapsulamento), la guarigione delle ferite e l'infiammazione produttiva.
La maturazione del tessuto di granulazione può avere certezza deviazioni. L'infiammazione che si sviluppa nel tessuto di granulazione porta ad un ritardo nella sua maturazione,
 Riso. 83. Tessuto di granulazione. Tra i vasi a parete sottile si trovano molte cellule di tessuto connettivo indifferenziato e fibre argirofile. Impregnazione d'argento
Riso. 83. Tessuto di granulazione. Tra i vasi a parete sottile si trovano molte cellule di tessuto connettivo indifferenziato e fibre argirofile. Impregnazione d'argento
e un'eccessiva attività sintetica dei fibroblasti porta ad un'eccessiva formazione di fibre di collagene, seguita da una pronunciata ialinosi. In questi casi, il tessuto cicatriziale appare sotto forma di una formazione simile a un tumore di colore rosso-bluastro, che sale sopra la superficie della pelle sotto forma cheloide. Le cicatrici cheloidi si formano dopo varie lesioni cutanee traumatiche, soprattutto dopo le ustioni.
Rigenerazione del tessuto adiposo avviene a causa della nuova formazione di cellule del tessuto connettivo, che si trasformano in cellule adipose (adipociti) attraverso l'accumulo di lipidi nel citoplasma. Le cellule di grasso sono piegate in lobuli, tra i quali si trovano strati di tessuto connettivo con vasi e nervi. La rigenerazione del tessuto adiposo può avvenire anche da residui nucleati del citoplasma delle cellule adipose.
Rigenerazione del tessuto osseo in caso di frattura ossea, dipende in gran parte dal grado di distruzione ossea, dal corretto riposizionamento dei frammenti ossei, dalle condizioni locali (stato circolatorio, infiammazione, ecc.). A semplice può verificarsi una frattura ossea, quando i frammenti ossei sono immobili unione ossea primaria(Fig. 84). Inizia con la crescita di giovani elementi e vasi mesenchimali nell'area del difetto e dell'ematoma tra i frammenti ossei. C'è un cosiddetto callo preliminare del tessuto connettivo, in cui inizia immediatamente la formazione ossea. È associato all'attivazione e alla proliferazione osteoblasti nell'area danneggiata, ma principalmente nel periostato e nell'endostato. Nel tessuto fibroreticolare osteogenico compaiono fasci ossei leggermente calcificati, il cui numero aumenta.
Formato callo preliminare. Successivamente matura e si trasforma in osso lamellare maturo: ecco come
 Riso. 84. Fusione ossea primaria. Callo intermedio (mostrato da una freccia), fusione di frammenti ossei (secondo G.I. Lavrishcheva)
Riso. 84. Fusione ossea primaria. Callo intermedio (mostrato da una freccia), fusione di frammenti ossei (secondo G.I. Lavrishcheva)
callo finale, che nella sua struttura differisce dal tessuto osseo solo per la disposizione casuale delle traverse ossee. Dopo che l'osso inizia a svolgere la sua funzione e appare un carico statico, il tessuto appena formato viene sottoposto a ristrutturazione con l'aiuto di osteoclasti e osteoblasti, appare il midollo osseo, la vascolarizzazione e l'innervazione vengono ripristinate. Se le condizioni locali per la rigenerazione ossea vengono violate (disturbi circolatori), si verificano mobilità dei frammenti, estese fratture diafisarie fusione ossea secondaria(Fig. 85). Questo tipo di fusione ossea è caratterizzato dalla formazione tra frammenti ossei del primo tessuto cartilagineo, sulla base del quale viene costruito il tessuto osseo. Si parla quindi di fusione ossea secondaria callo osteocondrale preliminare, che alla fine si sviluppa in osso maturo. La fusione ossea secondaria, rispetto alla fusione primaria, è molto più comune e richiede più tempo.
A condizioni sfavorevoli la rigenerazione ossea può essere compromessa. Pertanto, quando una ferita si infetta, la rigenerazione ossea viene ritardata. I frammenti ossei, che durante il normale corso del processo rigenerativo fungono da struttura per il tessuto osseo neoformato, in condizioni di suppurazione della ferita sostengono l'infiammazione, che inibisce la rigenerazione. Talvolta il callo osteocondrale primario non si differenzia in callo osseo. In questi casi, le estremità dell'osso rotto rimangono mobili e a falsa articolazione. L'eccessiva produzione di tessuto osseo durante la rigenerazione porta alla comparsa di speroni ossei - esostosi.
Rigenerazione del tessuto cartilagineo a differenza dell'osso, di solito si presenta in modo incompleto. Solo piccoli difetti possono essere sostituiti da tessuto neoformato a causa degli elementi cambiali del pericondrio - condroblasti. Queste cellule creano la sostanza fondamentale della cartilagine e poi si sviluppano in cellule cartilaginee mature. Grandi difetti cartilaginei vengono sostituiti da tessuto cicatriziale.
Rigenerazione del tessuto muscolare, le sue capacità e forme variano a seconda del tipo di tessuto. Liscio I muscoli, le cui cellule hanno la capacità di subire mitosi e amitosi, possono rigenerarsi abbastanza completamente con piccoli difetti. Aree significative di danno alla muscolatura liscia vengono sostituite da cicatrici, mentre le restanti fibre muscolari subiscono ipertrofia. La nuova formazione di fibre muscolari lisce può avvenire attraverso la trasformazione (metaplasia) degli elementi del tessuto connettivo. Così si formano fasci di fibre muscolari lisce nelle aderenze pleuriche, nei trombi in fase di organizzazione e nei vasi in fase di differenziazione.
Striato i muscoli si rigenerano solo se il sarcolemma è preservato. All'interno dei tubi del sarcolemma avviene la rigenerazione dei suoi organelli, con conseguente comparsa di cellule chiamate mioblasti. Si allungano, il numero di nuclei in essi aumenta, nel sarcoplasma
 Riso. 85. Fusione ossea secondaria (secondo G.I. Lavrishcheva):
Riso. 85. Fusione ossea secondaria (secondo G.I. Lavrishcheva):
a - callo periostale osteocondrale; una sezione di tessuto osseo tra tessuto cartilagineo (immagine microscopica); b - callo osteocondrale periostale (istotopogramma 2 mesi dopo l'intervento): 1 - parte ossea; 2 - parte cartilaginea; 3 - frammenti ossei; c - callo periostale, che fonde frammenti ossei spostati
le miofibrille si differenziano e i tubi sarcolemmali si trasformano in fibre muscolari striate. Può essere associata anche la rigenerazione dei muscoli scheletrici cellule satellitari, che si trovano sotto il sarcolemma, cioè all'interno della fibra muscolare, e sono cambiale. In caso di lesione, le cellule satellite iniziano a dividersi rapidamente, quindi subiscono la differenziazione e garantiscono il ripristino delle fibre muscolari. Se, quando un muscolo è danneggiato, l'integrità delle fibre viene interrotta, alle estremità delle loro rotture compaiono sporgenze a forma di fiasco, che contengono un gran numero di nuclei e sono chiamate reni muscolari. In questo caso non si verifica il ripristino della continuità della fibra. Il sito della rottura è pieno di tessuto di granulazione, che si trasforma in una cicatrice (callo muscolare). Rigenerazione muscoli cardiaci se è danneggiato, come nel caso dei muscoli striati, si conclude con la cicatrizzazione del difetto. Tuttavia, nelle restanti fibre muscolari si verifica un'intensa iperplasia delle ultrastrutture, che porta all'ipertrofia delle fibre e al ripristino della funzione degli organi (vedi Fig. 81).
Rigenerazione epiteliale nella maggior parte dei casi viene eseguito in modo abbastanza completo, poiché ha un'elevata capacità rigenerativa. Si rigenera particolarmente bene rivestimento dell'epitelio. Recupero epitelio squamoso cheratinizzante stratificato possibile anche con difetti della pelle abbastanza grandi. Durante la rigenerazione dell'epidermide ai bordi del difetto, si verifica una maggiore proliferazione delle cellule dello strato germinale (cambiale) e germinale (malpighiano). Le cellule epiteliali risultanti coprono prima il difetto in uno strato. Successivamente lo strato epiteliale diventa multistrato, le sue cellule si differenziano e acquisisce tutti i segni dell'epidermide, compresi lo strato germinale, granulare, lucido (sulla pianta e sulla superficie palmare delle mani) e corneo. Quando la rigenerazione dell'epitelio cutaneo è compromessa, si formano ulcere non cicatrizzate, spesso con crescita di epitelio atipico sui bordi, che possono servire come base per lo sviluppo del cancro della pelle.
Epitelio di copertura delle mucose (squamoso multistrato non cheratinizzato, transitorio, prismatico monostrato e ciliato multinucleato) si rigenera allo stesso modo dello squamoso multistrato cheratinizzato. Il difetto della mucosa viene ripristinato grazie alla proliferazione di cellule che rivestono le cripte e i dotti escretori delle ghiandole. Le cellule epiteliali appiattite indifferenziate ricoprono dapprima il difetto con uno strato sottile (Fig. 86), quindi le cellule assumono la forma caratteristica delle strutture cellulari del corrispondente rivestimento epiteliale. Parallelamente, le ghiandole della mucosa (ad esempio le ghiandole tubulari dell'intestino, le ghiandole endometriali) vengono parzialmente o completamente ripristinate.
Rigenerazione del mesotelio peritoneo, pleura e sacco pericardico viene effettuata dividendo le cellule sopravvissute. Sulla superficie del difetto compaiono cellule cubiche relativamente grandi, che poi si appiattiscono. Per piccoli difetti, il rivestimento mesoteliale viene ripristinato rapidamente e completamente.
La condizione del tessuto connettivo sottostante è importante per il ripristino dell'epitelio tegumentario e del mesotelio, poiché l'epitelizzazione di qualsiasi difetto è possibile solo dopo averlo riempito con tessuto di granulazione.
Rigenerazione dell'epitelio di organi specializzati(fegato, pancreas, reni, ghiandole endocrine, alveoli polmonari) viene effettuato a seconda della tipologia ipertrofia rigenerativa: nelle aree danneggiate, il tessuto viene sostituito da una cicatrice e lungo la sua periferia si verificano iperplasia e ipertrofia delle cellule del parenchima. IN fegato l'area di necrosi è sempre soggetta a cicatrici, ma nel resto dell'organo si osserva un'intensa formazione di nuove cellule, nonché un'iperplasia delle strutture intracellulari, accompagnata dalla loro ipertrofia. Di conseguenza, la massa e la funzione originali dell’organo vengono rapidamente ripristinate. Le capacità rigenerative del fegato sono quasi illimitate. Nel pancreas, i processi rigenerativi sono ben espressi sia nelle sezioni esocrine che nelle isole pancreatiche, e l'epitelio delle ghiandole esocrine diventa la fonte del ripristino delle isole. IN reni con la necrosi dell'epitelio tubulare, i nefrociti sopravvissuti si moltiplicano ed i tubuli si ripristinano, ma solo quando viene preservata la membrana basale tubulare. Quando viene distrutto (tubulorressi), l'epitelio non viene ripristinato e il tubulo viene sostituito dal tessuto connettivo. L'epitelio tubulare morto non viene ripristinato anche nel caso in cui il glomerulo vascolare muore contemporaneamente al tubulo. In questo caso, il tessuto connettivo cicatrizzato cresce al posto del nefrone morto e i nefroni circostanti subiscono un’ipertrofia rigenerativa. Nelle ghiandole secrezione interna i processi di ripristino sono rappresentati anche da rigenerazione incompleta. IN polmone dopo la rimozione dei singoli lobi, nella parte rimanente si verifica ipertrofia e iperplasia degli elementi tissutali. La rigenerazione dell'epitelio specializzato degli organi può procedere in modo atipico, il che porta alla proliferazione del tessuto connettivo, alla ristrutturazione strutturale e alla deformazione degli organi; in questi casi si parla cirrosi (cirrosi epatica, nefrocirrosi, pneumocirrosi).
Rigenerazione di diverse parti del sistema nervoso avviene in modo ambiguo. IN Testa E midollo spinale neoplasie delle cellule gangliari non producono
 Riso. 86. Rigenerazione dell'epitelio nel fondo di un'ulcera gastrica cronica
Riso. 86. Rigenerazione dell'epitelio nel fondo di un'ulcera gastrica cronica
avviene e quando vengono distrutte, il ripristino della funzione è possibile solo attraverso la rigenerazione intracellulare delle cellule sopravvissute. La neuroglia, in particolare la microglia, è caratterizzata da una forma di rigenerazione cellulare, pertanto i difetti nel tessuto del cervello e del midollo spinale sono solitamente pieni di cellule neurogliali proliferanti, le cosiddette gliale (gliotico) cicatrici. Se danneggiato nodi vegetativi Insieme all'iperplasia delle ultrastrutture cellulari, si verifica anche la loro nuova formazione. In caso di violazione dell'integrità nervo periferico la rigenerazione avviene grazie al segmento centrale, che ha mantenuto la connessione con la cellula, mentre il segmento periferico muore. Lungo di essa si trovano le cellule che si moltiplicano della guaina di Schwann del segmento periferico morto del nervo e formano una guaina, la cosiddetta corda di Büngner, nella quale crescono i cilindri assiali rigeneranti del segmento prossimale. La rigenerazione delle fibre nervose termina con la loro mielinizzazione e il ripristino delle terminazioni nervose. Iperplasia rigenerativa recettori, i dispositivi sinaptici e gli effettori pericellulari sono talvolta accompagnati da ipertrofia del loro apparato terminale. Se la rigenerazione del nervo viene interrotta per un motivo o per l'altro (divergenza significativa di parti del nervo, sviluppo di un processo infiammatorio), nel sito della sua rottura si forma una cicatrice in cui i cilindri assiali rigenerati del segmento prossimale del nervo sono posizionati in modo casuale. Crescite simili si verificano alle estremità dei nervi recisi nel moncone di un arto dopo l'amputazione. Vengono chiamate tali escrescenze formate da fibre nervose e tessuto fibroso neuromi da amputazione.
Guarigione delle ferite
La guarigione delle ferite procede secondo le leggi della rigenerazione riparativa. La velocità di guarigione della ferita e i suoi esiti dipendono dal grado e dalla profondità del danno della ferita, dalle caratteristiche strutturali dell'organo, dalle condizioni generali del corpo e dai metodi di trattamento utilizzati. Secondo I.V. Davydovsky, si distinguono i seguenti tipi di guarigione delle ferite: 1) chiusura diretta del difetto epiteliale; 2) guarigione sotto la crosta; 3) guarigione della ferita per intenzione primaria; 4) guarigione della ferita per seconda intenzione o guarigione della ferita attraverso suppurazione.
Chiusura diretta del difetto epiteliale- questa è la guarigione più semplice, che consiste nello strisciare l'epitelio sul difetto superficiale e nel ricoprirlo con uno strato epiteliale. Osservato sulla cornea, sulle mucose guarigione sotto la crosta riguarda piccoli difetti, sulla cui superficie appare rapidamente una crosta essiccante (crosta) di sangue coagulato e linfa; l'epidermide viene ripristinata sotto una crosta, che scompare 3-5 giorni dopo l'infortunio.
Guarigione per intenzione primaria (per rimamtentionem) osservato in ferite con danni non solo alla pelle, ma anche al tessuto sottostante,
e i bordi della ferita sono lisci. La ferita è piena di coaguli di sangue versato, che proteggono i bordi della ferita dalla disidratazione e dalle infezioni. Sotto l'influenza degli enzimi proteolitici dei neutrofili, si verifica la lisi parziale della coagulazione del sangue e dei detriti tissutali. I neutrofili muoiono e vengono sostituiti dai macrofagi, che fagocitano i globuli rossi e i resti del tessuto danneggiato; L'emosiderina si trova ai bordi della ferita. Parte del contenuto della ferita viene rimossa il primo giorno della ferita insieme all'essudato in modo indipendente o durante il trattamento della ferita - pulizia primaria. Nel 2-3° giorno, sui bordi della ferita compaiono fibroblasti e capillari neoformati, che crescono l'uno verso l'altro, tessuto di granulazione, il cui strato non raggiunge grandi dimensioni durante la tensione primaria. Entro il 10-15° giorno matura completamente, il difetto della ferita viene riepitelizzato e la ferita guarisce con una delicata cicatrice. In una ferita chirurgica, la guarigione per intenzione primaria è accelerata dal fatto che i suoi bordi sono serrati con fili di seta o catgut, attorno ai quali si accumulano cellule giganti di corpi estranei che li assorbono e non interferiscono con la guarigione.
Guarigione per intenzione secondaria (per secundamtentionem), o guarigione per suppurazione (o guarigione per granulazione - per granulazione), Di solito si osserva con ferite estese, accompagnate da schiacciamento e necrosi dei tessuti, penetrazione di corpi estranei e microbi nella ferita. Nel sito della ferita si verificano emorragie e rigonfiamenti traumatici dei bordi della ferita e compaiono rapidamente segni di demarcazione. infiammazione purulenta al confine con il tessuto morto, fusione delle masse necrotiche. Durante i primi 5-6 giorni le masse necrotiche vengono rigettate - secondario pulizia della ferita e il tessuto di granulazione inizia a svilupparsi sui bordi della ferita. tessuto di granulazione, riempimento della ferita, è costituito da 6 strati che si intersecano l'uno nell'altro (Anichkov N.N., 1951): strato superficiale leucocitario-necrotico; strato superficiale delle anse vascolari, strato dei vasi verticali, strato in maturazione, strato di fibroblasti disposti orizzontalmente, strato fibroso. La maturazione del tessuto di granulazione durante la guarigione delle ferite per seconda intenzione è accompagnata dalla rigenerazione epiteliale. Tuttavia, con questo tipo di guarigione della ferita, si forma sempre una cicatrice nella sua sede.
Rigenerazione- ripristino da parte del corpo di organi e tessuti persi o danneggiati, nonché ripristino dell'intero organismo da parte sua. In misura maggiore
in misura minore - inerente alle piante e agli animali invertebrati. La rigenerazione può essere causata
sperimentalmente.
Rigenerazioneè finalizzato al ripristino degli elementi strutturali danneggiati e ai processi di rigenerazione possibili
svolte a diversi livelli:
a) molecolare
b) subcellulare
c) cellulare - riproduzione cellulare per mitosi e via amitotica
d) tessuto
d) organo.
Tipi di rigenerazione:
7. Fisiologico - garantisce il funzionamento di organi e sistemi in condizioni normali. La rigenerazione fisiologica avviene in tutti gli organi, ma in alcuni di più, in altri meno.
2. Riparativo(restaurativo) - si verifica in connessione con un processo patologico che porta al danno tissutale (si tratta di una rigenerazione fisiologica migliorata)
a) rigenerazione completa (restituzione): esattamente lo stesso tessuto appare nel sito del danno tissutale
b) rigenerazione incompleta (sostituzione): il tessuto connettivo appare al posto del tessuto morto. Ad esempio, nel cuore durante un infarto miocardico si verifica la necrosi, che viene sostituita dal tessuto connettivo.
Il significato di rigenerazione incompleta: l'ipertrofia rigenerativa si verifica attorno al tessuto connettivo, che
garantisce la conservazione della funzione dell'organo danneggiato.
Ipertrofia rigenerativa effettuato attraverso:
a) iperplasia cellulare (formazione eccessiva)
b) ipertrofia cellulare (aumento del volume e del peso degli organi).
L'ipertrofia rigenerativa nel miocardio viene effettuata a causa dell'iperplasia delle strutture intracellulari.
Forme di rigenerazione.
1. Cellulare: la riproduzione cellulare avviene in modo mitotico e amitotico. Esiste nel tessuto osseo, nell'epidermide, nella mucosa gastrointestinale, nella mucosa respiratoria, nella mucosa genito-urinaria, nell'endotelio, nel mesotelio, nel tessuto connettivo lasso, nel sistema ematopoietico. La rigenerazione completa avviene in questi organi e tessuti (esattamente lo stesso tessuto).
2. Intracellulare: si verifica l'iperplasia delle strutture intracellulari. Miocardio, muscoli scheletrici (principalmente), cellule gangliari del sistema nervoso centrale (esclusivamente).
3. Forme cellulari e intracellulari. Fegato, reni, polmoni, muscolatura liscia, sistema nervoso autonomo, pancreas, sistema endocrino. Di solito si verifica una rigenerazione incompleta.
Rigenerazione del tessuto connettivo.
Fasi:
1. Formazione di tessuto di granulazione. A poco a poco, i vasi e le cellule vengono spostati con la formazione di fibre. I fibroblasti sono fibrociti che producono fibre.
2. Formazione di tessuto connettivo maturo. Rigenerazione del sangue
1. Rigenerazione fisiologica. Nel midollo osseo.
2. Rigenerazione riparativa. Si manifesta con anemia, leucopenia, trombocitopenia. Appaiono focolai extramidollari di emopoiesi (nel fegato, nella milza, nei linfonodi, il midollo osseo giallo è coinvolto nell'ematopoiesi).
3. Rigenerazione patologica. Per la malattia da radiazioni, la leucemia. Negli organi ematopoietici, immaturi
elementi ematopoietici (celle energetiche).
Domanda 16
OMEOSTASI.
Omeostasi – mantenere la costanza dell’ambiente interno del corpo in condizioni ambientali in continuo cambiamento. Perché l'organismo è un oggetto autoregolante a più livelli e può essere considerato dal punto di vista della cibernetica. Quindi, il corpo è un complesso sistema autoregolante a più livelli con molte variabili.
Variabili di input:
Causa;
Irritazione.
Variabili di uscita:
Reazione;
Conseguenza.
Il motivo è una deviazione dalla normale reazione del corpo. Il feedback gioca un ruolo decisivo. Ci sono feedback positivi e negativi.
Feedback negativo riduce l'effetto del segnale di ingresso sul segnale di uscita. Riscontro positivo aumenta l'effetto del segnale di ingresso sull'effetto di uscita dell'azione.
Un organismo vivente è un sistema ultrastabile che ricerca lo stato stabile più ottimale, garantito dagli adattamenti.
Domanda 18:
PROBLEMI DI TRAPIANTO.
Il trapianto è il trapianto di tessuti e organi.
Il trapianto negli animali e nell'uomo è l'attecchimento di organi o sezioni di singoli tessuti per sostituire difetti, stimolare la rigenerazione, durante operazioni cosmetiche, nonché a fini sperimentali e di terapia tissutale.
L’autotrapianto è un trapianto di tessuto all’interno di un organismo, mentre l’allotrapianto è un trapianto tra organismi della stessa specie. Lo xenotrapianto è un trapianto tra specie diverse.
Domanda 19
Cronobiologia- una branca della biologia che studia i ritmi biologici, il corso di vari processi biologici
(prevalentemente ciclico) nel tempo.
Ritmi biologici- (bioritmi), fluttuazioni cicliche nell'intensità e nella natura dei processi e dei fenomeni biologici. Alcuni ritmi biologici sono relativamente indipendenti (ad esempio la frequenza delle contrazioni cardiache, la respirazione), altri sono associati all'adattamento degli organismi ai cicli geofisici - quotidiani (ad esempio, fluttuazioni nell'intensità della divisione cellulare, metabolismo, attività motoria degli animali ), marea (ad esempio processi biologici negli organismi associati al livello delle maree marine), annuale (cambiamenti nel numero e nell'attività degli animali, crescita e sviluppo delle piante, ecc.). La scienza dei ritmi biologici è la cronobiologia.
Domanda 20
FILOGENESI SCHELETRICA
Lo scheletro del pesce è costituito da un cranio, una colonna vertebrale, uno scheletro di pinne spaiate e accoppiate e le loro cinture. Nella regione del tronco, le costole sono attaccate ai processi trasversali del corpo. Le vertebre si articolano tra loro utilizzando processi articolari, fornendo flessione principalmente sul piano orizzontale.
Lo scheletro degli anfibi, come tutti i vertebrati, è costituito dal cranio, dalla colonna vertebrale, dallo scheletro degli arti e dalle loro cinture. Il cranio è quasi interamente cartilagineo (Fig. 11.20). È articolato in modo mobile con la colonna vertebrale. La colonna vertebrale contiene nove vertebre, unite in tre sezioni: cervicale (1 vertebra), tronco (7 vertebre), sacrale (1 vertebra) e tutte le vertebre caudali sono fuse per formare un unico osso: l'urostilo. Non ci sono costole. Il cingolo scapolare comprende le ossa tipiche dei vertebrati terrestri: scapole accoppiate, ossa di corvo (coracoidi), clavicole e sterno spaiato. Ha l'aspetto di un semianello che giace nello spessore dei muscoli del tronco, cioè non è collegato alla colonna vertebrale. La cintura pelvica è formata da due ossa pelviche, formate da tre paia di ossa iliache, ischiatiche e pubiche fuse insieme. Le lunghe ossa iliache sono attaccate ai processi trasversali della vertebra sacrale. Lo scheletro degli arti liberi è costruito secondo il tipo di sistema di leve a più membri, collegate in modo mobile da giunti sferici. Come parte della zampa anteriore. distinguere la spalla, l'avambraccio e la mano.
Il corpo della lucertola è diviso in testa, busto e coda. Nella sezione del tronco il collo è ben definito. L'intero corpo è ricoperto di scaglie cornee e la testa e il ventre sono ricoperti da grandi scudi. Gli arti della lucertola sono ben sviluppati e armati di cinque dita munite di artigli. Le ossa dell'omero e del femore sono parallele alla superficie del terreno, facendo sì che il corpo si pieghi e tocchi il suolo (da cui il nome della classe). La colonna cervicale è composta da otto vertebre, la prima delle quali è collegata in modo mobile sia al cranio che alla seconda vertebra, che conferisce alla testa una maggiore libertà di movimento. Le vertebre della regione toracolombare portano costole, alcune delle quali sono collegate allo sterno, dando luogo alla formazione della gabbia toracica. Le vertebre sacrali forniscono una connessione più forte con le ossa pelviche rispetto agli anfibi.
La struttura dello scheletro dei mammiferi è sostanzialmente simile a quella dei vertebrati terrestri, ma vi sono alcune differenze: il numero delle vertebre cervicali è costante e pari a sette, il cranio è più voluminoso, il che si associa alle maggiori dimensioni del cervello. Le ossa del cranio si fondono abbastanza tardi, consentendo al cervello di crescere man mano che l'animale cresce. Gli arti dei mammiferi sono costruiti secondo il tipo a cinque dita, caratteristico dei vertebrati terrestri.
Domanda 21
FILOGENESI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
Il sistema circolatorio del pesce è ostruito. Il cuore è bicamerale, costituito da un atrio e un ventricolo. Il sangue venoso dal ventricolo del cuore entra nell'aorta addominale, che lo trasporta alle branchie, dove si arricchisce di ossigeno e liberato dall'anidride carbonica. Il sangue arterioso che scorre dalle branchie viene raccolto nell'aorta dorsale, che si trova lungo il corpo sotto la colonna vertebrale. Dall'aorta dorsale si dipartono numerose arterie che portano ai vari organi dei pesci. In essi, le arterie si dividono in una rete di capillari molto sottili, attraverso le cui pareti il sangue rilascia ossigeno e si arricchisce di anidride carbonica. Il sangue venoso si raccoglie nelle vene e scorre attraverso di esse nell'atrio e da esso nel ventricolo. Di conseguenza, i pesci hanno una circolazione.
Il sistema circolatorio degli anfibi è rappresentato da un cuore a tre camere, costituito da due atri e un ventricolo, e due circoli di circolazione sanguigna: grande (tronco) e piccolo (polmonare). La circolazione polmonare inizia nel ventricolo, comprende i vasi polmonari e termina nell'atrio sinistro. Anche il circolo massimo inizia nel ventricolo. Il sangue, dopo aver attraversato i vasi di tutto il corpo, ritorna nell'atrio destro. Pertanto, il sangue arterioso proveniente dai polmoni entra nell'atrio sinistro e il sangue venoso proveniente da tutto il corpo entra nell'atrio destro. Anche il sangue arterioso che scorre dalla pelle entra nell'atrio destro. Così, grazie alla comparsa della circolazione polmonare, il sangue arterioso entra anche nel cuore degli anfibi. Nonostante il fatto che il sangue arterioso e venoso entri nel ventricolo, la completa miscelazione del sangue non avviene a causa della presenza di tasche e partizioni incomplete. Grazie a loro, quando esce dal ventricolo, il sangue arterioso scorre attraverso le arterie carotidi nella testa, il sangue venoso nei polmoni e nella pelle e il sangue misto in tutti gli altri organi del corpo. Pertanto, negli anfibi non esiste una completa separazione del sangue nel ventricolo, quindi l'intensità dei processi vitali è bassa e la temperatura corporea è variabile.
Il cuore dei rettili è a tre camere, ma non si verifica una completa miscelazione del sangue arterioso e venoso a causa della presenza di un setto longitudinale incompleto. Tre vasi che si estendono da diverse parti del ventricolo - l'arteria polmonare, gli archi aortici sinistro e destro - trasportano il sangue venoso ai polmoni, il sangue arterioso alla testa e agli arti anteriori e alle restanti parti - mescolato con una predominanza di sangue arterioso. Tale afflusso di sangue, così come una bassa capacità di termoregolazione, porta al fatto che
La temperatura corporea dei rettili dipende dalle condizioni di temperatura dell'ambiente.
L'alto livello di attività vitale degli uccelli è dovuto a un sistema circolatorio più avanzato rispetto agli animali delle classi precedenti. Avevano una completa separazione dei flussi sanguigni arteriosi e venosi. Ciò è dovuto al fatto che il cuore degli uccelli è a quattro camere ed è completamente diviso nelle parti arteriosa sinistra e venosa destra. L'arco aortico è unico (quello destro) e nasce dal ventricolo sinistro. In esso scorre sangue arterioso puro, che fornisce tutti i tessuti e gli organi del corpo. L'arteria polmonare parte dal ventricolo destro e trasporta il sangue venoso ai polmoni. Il sangue si muove rapidamente attraverso i vasi, lo scambio di gas avviene in modo intenso e viene rilasciato molto calore. Il sistema circolatorio dei mammiferi non è fondamentalmente diverso da quello degli uccelli: a differenza degli uccelli, nei mammiferi l'arco aortico sinistro parte dal ventricolo sinistro.
Domanda 22
SVILUPPO DEGLI ARCHI ARTERIOSI
Archi arteriosi, archi aortici, vasi sanguigni che si formano negli embrioni dei vertebrati sotto forma di 6-7 (nei ciclostomi fino a 15) tronchi laterali accoppiati che si estendono dall'aorta addominale. d.C. passano lungo i setti interbranchiali fino al lato dorsale della faringe e, fondendosi, formano l'aorta dorsale. Le prime 2 paia di archi arteriosi vengono solitamente ridotti precocemente; nelle larve di pesci e anfibi si conservano sotto forma di piccoli vasi. Le restanti 4-5 paia di archi arteriosi diventano vasi branchiali. Nei vertebrati terrestri, le arterie carotidi sono formate dal terzo paio di archi arteriosi e le arterie polmonari dal sesto. Negli anfibi caudati, solitamente la 4a e la 5a coppia di archi arteriosi formano i tronchi o le radici dell'aorta, fondendosi nell'aorta dorsale. Negli anfibi e nei rettili senza coda, gli archi aortici nascono solo dal 4o paio di archi arteriosi e il 5o è ridotto. Negli uccelli e nei mammiferi il 5° e la metà del 4° arco arterioso sono ridotti; negli uccelli la metà destra diventa l'aorta; nei mammiferi la metà sinistra diventa l'aorta. Talvolta negli individui adulti si conservano i vasi embrionali che collegano gli archi aortici con le arterie carotidee (dotti carotidi) o polmonari (dotti botallici).
Domanda 23
Sistema respiratorio.
La maggior parte degli animali sono aerobi. La diffusione dei gas dall'atmosfera attraverso una soluzione acquosa avviene durante la respirazione. Elementi di pelle e respirazione dell'acqua sono preservati anche nei vertebrati superiori. Nel corso dell'evoluzione, gli animali hanno sviluppato una varietà di dispositivi respiratori, derivati della pelle e del tubo digerente. Le branchie e i polmoni sono derivati della faringe.
FILOGENESI DEGLI ORGANI RESPIRATORI
Gli organi respiratori - le branchie - si trovano sul lato superiore dei quattro archi branchiali sotto forma di petali rosso vivo. L'acqua entra nella bocca del pesce, viene filtrata attraverso le fessure branchiali, lavando le branchie e viene scaricata da sotto la copertura branchiale. Lo scambio gassoso avviene in numerosi capillari branchiali, nei quali il sangue scorre verso l'acqua che lava le branchie.
Le rane respirano attraverso i polmoni e la pelle. I polmoni sono sacche cave accoppiate con una superficie interna cellulare, penetrata da una rete di capillari sanguigni, dove avviene lo scambio di gas. Il meccanismo respiratorio degli anfibi è imperfetto, del tipo a pressione. L'animale aspira aria nella cavità orofaringea, per la quale abbassa il fondo della bocca e apre le narici. Quindi le narici si chiudono con le valvole, il pavimento della bocca si solleva e l'aria viene forzata nei polmoni. L'aria viene rimossa dai polmoni contraendo i muscoli pettorali. La superficie dei polmoni degli anfibi è piccola, più piccola della superficie della pelle.
Organi respiratori - polmoni (rettili). Le loro pareti hanno una struttura cellulare, che aumenta notevolmente la superficie. Non c'è respirazione cutanea. La ventilazione dei polmoni è più intensa che negli anfibi ed è associata a cambiamenti nel volume del torace. Le vie respiratorie - trachea, bronchi - proteggono i polmoni dagli effetti essiccanti e rinfrescanti dell'aria proveniente dall'esterno.
I polmoni degli uccelli sono corpi densi e spugnosi. I bronchi, entrati nei polmoni, si ramificano fortemente in essi fino ai bronchioli più sottili, chiusi ciecamente, impigliati in una rete di capillari, dove
e avviene lo scambio di gas. Alcuni dei grandi bronchi, senza ramificazioni, si estendono oltre i polmoni e si espandono in enormi sacche d'aria a pareti sottili, il cui volume è molte volte maggiore del volume dei polmoni (Fig. 11.23). Le sacche d'aria si trovano tra vari organi interni e i loro rami passano tra i muscoli, sotto la pelle e nelle cavità delle ossa.
I mammiferi respirano con polmoni che hanno una struttura alveolare, grazie alla quale la superficie respiratoria supera la superficie del corpo di 50 volte o più. Il meccanismo respiratorio è causato da un cambiamento nel volume del torace dovuto al movimento delle costole e da uno speciale muscolo caratteristico dei mammiferi: il diaframma.
Domanda 24
FILOGENESI DEL CERVELLO
Il sistema nervoso centrale dei pesci è costituito dal cervello e dal midollo spinale. Il cervello dei pesci, come in tutti i vertebrati, è rappresentato da cinque sezioni: prosencefalo, intermedio, medio, cervelletto e midollo allungato. I lobi olfattivi ben sviluppati si estendono dal prosencefalo. Il mesencefalo, che analizza le percezioni visive, così come il cervelletto, che regola la coordinazione dei movimenti e il mantenimento dell'equilibrio, raggiunge il massimo sviluppo.
Il cervello degli anfibi ha le stesse cinque sezioni del cervello dei pesci. Se ne differenzia però per il maggiore sviluppo del prosencefalo, che negli anfibi è diviso in due emisferi. Il cervelletto è sottosviluppato a causa della scarsa mobilità e della monotonia. diversi modelli di movimenti degli anfibi.
Il cervello dei rettili, rispetto a quello degli anfibi, ha un cervelletto e emisferi cerebrali del prosencefalo più sviluppati, sulla cui superficie sono presenti i rudimenti della corteccia. Ciò provoca varie e più complesse forme di comportamento adattivo.
Il cervello degli uccelli differisce dal cervello dei rettili per le grandi dimensioni degli emisferi del prosencefalo e del cervelletto.
Il cervello dei mammiferi è relativamente grande a causa dell'aumento del volume del prosencefalo e del cervelletto. Lo sviluppo del prosencefalo avviene a causa della crescita del suo tetto: la volta cerebrale o la corteccia cerebrale.
Domanda 25
FILOGENESI DEI SISTEMI ESCRERETORI E GENERALI
Gli organi escretori dei pesci sono gemme del tronco a forma di nastro accoppiate situate nella cavità del corpo sotto la colonna vertebrale. Hanno perso il contatto con la cavità corporea e rimuovono i prodotti di scarto nocivi, filtrandoli dal sangue. Nei pesci d'acqua dolce, il prodotto finale del metabolismo delle proteine è l'ammoniaca tossica. Si dissolve in una grande quantità di acqua e quindi i pesci espellono molta urina liquida. L'acqua escreta con le urine viene facilmente reintegrata grazie al suo costante apporto attraverso la pelle, le branchie e con il cibo. Nei pesci marini, il prodotto finale del metabolismo dell'azoto è l'urea meno tossica, la cui eliminazione richiede meno acqua. L'urina formata nei reni scorre attraverso gli ureteri accoppiati nella vescica, da dove viene espulsa attraverso l'apertura escretrice. Le ghiandole sessuali accoppiate - ovaie e testicoli - hanno dotti escretori. La fecondazione nella maggior parte dei pesci è esterna e avviene in acqua.
Gli organi emuntori degli anfibi, come quelli dei pesci, sono rappresentati dai reni del tronco. Tuttavia, a differenza dei pesci, hanno l'aspetto di corpi compatti appiattiti, adagiati sui fianchi
vertebra sacrale. I reni contengono glomeruli che filtrano dal sangue i prodotti di degradazione nocivi (principalmente l'urea) e allo stesso tempo le sostanze importanti per l'organismo (zuccheri, vitamine, ecc.). Durante il flusso attraverso i tubuli renali, le sostanze utili all'organismo vengono riassorbite nel sangue e l'urina scorre attraverso due ureteri nella cloaca e da lì nella vescica. Dopo che la vescica si è riempita, le sue pareti muscolari si contraggono, l'urina viene rilasciata nella cloaca ed espulsa. La perdita di acqua dal corpo degli anfibi con l'urina, così come nei pesci, viene reintegrata dalla sua assunzione attraverso la pelle. Le gonadi sono accoppiate. Gli ovidotti accoppiati sfociano nella cloaca e i dotti deferenti negli ureteri.
Gli organi escretori dei rettili sono rappresentati dai reni pelvici, in cui l'area di filtrazione totale dei glomeruli è piccola, mentre la lunghezza dei tubuli è significativa. Ciò favorisce il riassorbimento intensivo dell'acqua filtrata dai glomeruli nei capillari sanguigni. Di conseguenza, l'escrezione dei prodotti di scarto nei rettili avviene con una perdita d'acqua minima. In essi, come negli artropodi terrestri, il prodotto finale dell'escrezione è l'acido urico, che richiede una piccola quantità di acqua per essere escreto dal corpo. L'urina viene raccolta attraverso gli ureteri nella cloaca e da questa nella vescica, dalla quale viene espulsa come sospensione di piccoli cristalli.
Isolamento dei mammiferi. I reni pelvici dei mammiferi sono simili nella struttura a quelli degli uccelli. L'urina con un alto contenuto di urea scorre dai reni attraverso gli ureteri nella vescica e fuori da essa.
Domanda 26
Filogenesi del tegumento corporeo:
Le principali direzioni di evoluzione dei tegumenti cordati:
1) differenziazione in due strati: esterno - epidermide, interno - derma e aumento dello spessore del derma;
1) dall'epidermide monostrato a multistrato;
2) differenziazione del derma in 2 strati: papillare e reticolare:
3) comparsa del grasso sottocutaneo e miglioramento dei meccanismi di termoregolazione;
4) dalle ghiandole unicellulari a quelle pluricellulari;
5) differenziazione di vari derivati cutanei.
Nei cordati inferiori (lancetta) l'epidermide è monostrato, cilindrica e presenta cellule ghiandolari che secernono muco. Il derma (corio) è rappresentato da un sottile strato di tessuto connettivo non formato.
Nei vertebrati inferiori, l'epidermide diventa multistrato. Il suo strato inferiore è germinale (basale), le sue cellule si dividono e ricostituiscono le cellule degli strati sovrastanti. Il derma ha localizzato correttamente fibre, vasi e nervi.
I derivati della pelle sono: ghiandole mucose unicellulari (nei pesci ciclostomi) e multicellulari (negli anfibi); squame: a) placoide nei pesci cartilaginei, al cui sviluppo prendono parte l'epidermide e il derma; b) osseo nei pesci ossei, che si sviluppa a spese del derma.
La scaglia placoide è ricoperta esternamente da uno strato di smalto (origine ectodermica), sotto il quale si trovano dentina e polpa (origine mesoderma). Le squame e il muco svolgono una funzione protettiva.
Gli anfibi hanno la pelle sottile e liscia senza squame. La pelle contiene un gran numero di ghiandole mucose multicellulari, la cui secrezione idrata il tegumento e ha proprietà battericide. La pelle prende parte allo scambio di gas.
Nei vertebrati superiori, a causa del raggiungimento della terra, l'epidermide diventa secca e presenta uno strato corneo.
Nei rettili Si sviluppano squame cornee e le ghiandole cutanee sono assenti.
Nei mammiferi: l'epidermide e il derma sono ben sviluppati, appare tessuto adiposo sottocutaneo.
Domanda 27
FILOGENESI DEL SISTEMA DIGERENTE.
I pesci mangiano una varietà di cibi. La specializzazione alimentare si riflette nella struttura degli organi digestivi. La bocca conduce alla cavità orale, che di solito contiene numerosi denti situati sulla mascella, sul palato e su altre ossa. Non ci sono ghiandole salivari. Dalla cavità orale, il cibo passa nella faringe, perforata dalle fessure branchiali, e attraverso l'esofago entra nello stomaco, le cui ghiandole secernono abbondantemente succhi digestivi. Alcuni pesci (ciprinidi e molti altri) non hanno stomaco e il cibo entra direttamente nell'intestino tenue, dove, sotto l'influenza di un complesso di enzimi secreti dalle ghiandole dell'intestino stesso, fegato e pancreas, il cibo viene i nutrienti scomposti e disciolti vengono assorbiti. La differenziazione del sistema digestivo degli anfibi è rimasta approssimativamente allo stesso livello di quella dei loro antenati: i pesci. La cavità orofaringea comune passa nell'esofago corto, dietro il quale si trova uno stomaco debolmente separato, che passa senza un confine netto nell'intestino. L'intestino termina con il retto, che passa nella cloaca. I dotti delle ghiandole digestive - fegato e pancreas - sfociano nel duodeno. I dotti delle ghiandole salivari, assenti nei pesci, si aprono nella cavità orofaringea e bagnano la cavità orale e il cibo. Lo stile di vita terrestre è associato alla comparsa di una vera e propria lingua nella cavità orale, organo principale per procurarsi il cibo.
Nell'apparato digerente dei rettili la differenziazione in sezioni è migliore di quella degli anfibi. Il cibo viene catturato dalle mascelle dotate di denti per trattenere la preda. La cavità orale è meglio delimitata dalla faringe che negli anfibi. Sul fondo della cavità orale è presente una lingua mobile, biforcuta all'estremità. Il cibo è inumidito con la saliva, che lo rende più facile da deglutire. L'esofago è lungo a causa dello sviluppo del collo. Lo stomaco, delimitato dall'esofago, ha pareti muscolari. Al confine tra l'intestino tenue e quello crasso si trova il cieco. Condotti del fegato e del pancreas
Le ghiandole si aprono nel duodeno. Il tempo necessario per digerire il cibo dipende dalla temperatura corporea dei rettili.
Apparato digerente dei mammiferi. I denti si trovano nelle cellule delle ossa mascellari e sono divisi in incisivi, canini e molari. L'apertura della bocca è circondata da labbra carnose, caratteristica solo dei mammiferi a causa dell'alimentazione con latte. Nella cavità orale il cibo, oltre ad essere masticato dai denti, viene influenzato chimicamente dagli enzimi salivari, per poi passare successivamente nell'esofago e nello stomaco. Lo stomaco nei mammiferi è ben separato dalle altre parti del tubo digerente ed è dotato di ghiandole digestive. Nella maggior parte delle specie di mammiferi, lo stomaco è diviso in più o meno sezioni. È più complesso negli artiodattili dei ruminanti. L'intestino ha sezioni sottili e spesse. Al confine tra la sezione sottile e quella spessa emerge il cieco, nel quale fermenta la fibra. I dotti del fegato e del pancreas si aprono nella cavità del duodeno.
Domanda 28
Sistema endocrino.
Qualsiasi organismo produce composti che sono distribuiti in tutto il corpo e hanno un ruolo integrativo. Le piante hanno fitormoni che controllano la crescita, lo sviluppo dei frutti, dei fiori, lo sviluppo dei germogli ascellari, la divisione del cambio, ecc. Le alghe unicellulari hanno fitormoni.
Gli ormoni sono comparsi negli organismi multicellulari quando sono sorte speciali cellule endocrine. Tuttavia, i composti chimici che svolgono il ruolo degli ormoni esistevano già prima. Tiroxina e triiodotironina (ghiandola tiroidea) sono state trovate nei cianobatteri. La regolazione ormonale negli insetti è poco conosciuta.
Nel 1965 Wilson isolò l’insulina dalle stelle marine.
Si è scoperto che definire l'ormone è molto difficile.
Ormoneè una sostanza chimica specifica secreta da cellule specifiche in un'area specifica del corpo, che entra nel flusso sanguigno e quindi ha un effetto specifico su cellule specifiche o organi bersaglio situati in altre aree del corpo, che porta alla coordinazione del funzioni dell'intero organismo nel suo insieme.
È noto un gran numero di ormoni dei mammiferi. Sono divisi in 3 gruppi principali.
Feromoni. Rilasciato nell'ambiente esterno. Con il loro aiuto, gli animali ricevono e trasmettono informazioni. Nell'uomo l'odore dell'acido 14-idrossitetradecanoico è chiaramente distinguibile solo dalle donne che hanno raggiunto la pubertà.
Gli organismi multicellulari organizzati in modo più semplice, ad esempio le spugne, hanno anche una parvenza di sistema endocrino. Le spugne sono costituite da 2 strati: endoderma ed esoderma; tra loro c'è il mesenchima, che contiene composti macromolecolari caratteristici del tessuto connettivo di organismi più altamente organizzati. Il mesenchima contiene cellule migranti; alcune cellule sono in grado di secernere serotonina e acetilcolina. Le spugne non hanno un sistema nervoso. Le sostanze sintetizzate nel mesenchima servono a collegare le singole parti del corpo. La coordinazione avviene attraverso il movimento delle cellule lungo il mesenchima. C'è anche il trasferimento di sostanze tra le cellule. Vengono poste le basi per la segnalazione chimica, caratteristica di altri animali. Non esistono cellule endocrine indipendenti.
I celenterati hanno un sistema nervoso primitivo. Inizialmente, le cellule nervose svolgevano una funzione neurosecretoria. La funzione trofica controllava la crescita e lo sviluppo dell'organismo. Quindi le cellule nervose iniziarono ad allungarsi e a formare lunghi processi. La secrezione veniva rilasciata vicino all'organo bersaglio, senza trasferimento (poiché non c'era sangue). Il meccanismo endocrino è sorto prima del meccanismo di conduzione. Le cellule nervose erano endocrine e quindi acquisivano proprietà conduttrici. Le cellule neurosecretorie furono le prime cellule secretrici.
Protostomi e deuterostomi producono gli stessi ormoni steroidei e peptidici. È generalmente accettato che nel processo di evoluzione ne possano derivare di nuovi (mutazioni, duplicazioni geniche) da alcuni ormoni polipeptidici. Le duplicazioni sono meno soppresse dalla selezione naturale rispetto alle mutazioni. Molti ormoni possono essere sintetizzati non in una ghiandola, ma in diverse. Ad esempio, l'insulina viene prodotta nel pancreas, nella ghiandola sottomandibolare, nel duodeno e in altri organi. Esiste una dipendenza dei geni che controllano la sintesi ormonale dalla posizione.

